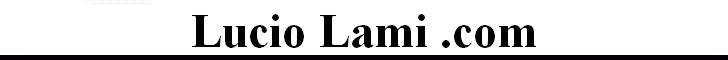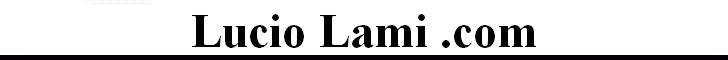» Articoli - 21 giugno 2010
«
Diritti umani a Cuba
Ogni volta che la Commissione dell’ONU per
i diritti umani, dopo aver ammesso i suoi fallimenti, fa capire
che Cuba potrebbe essere condannata per le sue innumerevoli violazioni,
la pochade ricomincia.
E i protagonisti sono sempre gli stessi: quelli che
Castro ha ricoperto d’onori per tenerseli buoni (scrittori,
musicisti, artisti, sportivi) che poi devono ricambiare.
Quelli che con Cuba fanno affari d’oro e che quindi invocano
la quiet diplomacy. Quelli che all’Avana vanno in
viaggio ufficiale, percorrono l’itinerario standard e si abbuffano
ai pranzi di corte, senza mai mettere il naso nella casa di un popolano.
Quelli che, come intellettuali, credono che non si possa essere
progressisti senza essere anti-americani e quindi filo castristi,
come Samargo, la Gordimer, Esquivel.
Quelli che, essendo nostalgici del vetero-comunismo, vedono in Cuba
il puerto escondido dove sopravvive uno stalinismo sorridente
e ballabile, come Niemeyer e i firmatari d’appelli pro-Castro.
Quelli che dei colloqui-serenata con Castro hanno fatto un’industria,
come Minà e Marquez.
Quelli che, a frotte, vanno a Cuba, per turismo, sessuale e no,
e che passano dall’ex Hilton alle sabbie di Varadero senza
accorgersi di nulla o fingendo di non vedere.
Contro questo nutrito esercito di supporters,
si schierano gli altri, coloro che pensano che attaccando Castro
si danneggi la sinistra. Dubito che sia vero.
La verità è che i diritti umani interessano a pochi.
Di questi tempi, anche i paesi democratici tendono ad usare due
pesi e due misure e le dittature amiche diventano meno condannabili
che quelle nemiche.
Sono vent’anni che a Cuba schiere d’intellettuali
denunciano la totale mancanza di libertà d’espressione.
Fui il primo giornalista ad intervistare i loro leaders, per questo
giornale, nel 1986. Li incontrai di notte, in riva al mare, freschi
di carcere e mi raccontarono la verità sulle prigioni cubane.
L’indomani, mentre rientravo in Italia, i tre coraggiosi (Elisandro
Sanchez, Adolfo Rivero ed Enrique Hernandez) furono nuovamente oggetto
di caccia grossa. Molto più tardi, uno di loro, tornato in
libertà, mi raccontò: ”Siamo stati picchiati
a lungo. Tra l’altro volevano che firmassimo una carta dove
lei era indicato come agente della Cia”.
Il fatto era grave, aveva coinvolto altri, come Bofil, il capo del
movimento, che si rifugiò nell’ambasciata francese.
Ma non ci fu scandalo.
Così com’era accaduto per l’Urss,
anche per Cuba si fanno convivere la realtà e la surrealtà.
L’ultima volta che vi andai, prima che mi cacciassero, nella
farmacia principale della città non si trovava neppure l’aspirina,
ma sui giornali che mi ero portato dall’Italia leggevo delle
meraviglie del servizio sanitario cubano. Ed era inutile spiegare
che anche a Mosca c’era l’ospedale modello, per i capi
del partito e gli stranieri in visita.
Alla mia amica Maria Elena Cruz Varela, la più grande poetessa
cubana vivente, vincitrice del Premio Nazionale di Poesia dell’Unione
degli scrittori cubani, mandarono in casa – dopo che aveva
firmato un appello libertario – gli squadristi del regime
che la picchiarono a sangue, la costrinsero a mangiare il manoscritto
delle sue poesie. Poi fu condannata a due anni di prigione.
Da almeno trent’anni, cioè dai tempi
dell’incarcerazione e tortura del poeta Padilla, a Cuba si
pratica una repressione violenta contro chiunque sia diversamente
pensante. Ma l’Occidente vive di leggende. La leggenda dei
successi della rivoluzione, che non è mai venuta meno, neppure
quando la fame straziava i cubani, neppure quando la fuga dall’isola
divenne un fenomeno di massa stroncato solo dalla forza poliziesca.
Per molti, ”i governi devono essere giudicati
solo per quel che realizzano nel campo dell’istruzione, della
sanità, del lavoro”, ma con questo metro finiremmo
per erigere monumenti a Pinochet, Franco e Salazar. Pochi, a sinistra,
notano la contraddizione.
Qualche ingenuo, come Abbado, ci dice che a Cuba
ci sono bellissimi orti e ottimi giovani dediti alla musica e al
balletto. Altri, meno candidi, ci parlano di un Castro che “dopotutto
ha tolto l’isola dall’ignoranza e dalla miseria”.
Fiabe. A Cuba, prima della rivoluzione, il livello di alfabetizzazione
era dell’80%, superiore a quello della Spagna (30 mila classi
elementari, 34 mila insegnanti di ruolo). Cuba era al 22° posto
nella classifica mondiale della sanità, con 128 medici ogni
100 mila abitanti (superando la Francia, l’Olanda e il Regno
unito). Questi fatti erano noti, tanto che nel 1959 gli uffici consolari
cubani a Roma furono travolti da 12mila richieste di italiani che
volevano emigrare a Cuba.
Il mito cubano che serve a creare dubbi sulla realtà
dell’isola, è nato al tempo in cui Cuba era una portaerei
fissa dell’Urss. Mosca assegnava a Cuba 5000 milioni di dollari
l’anno. Il totale dei sussidi ricevuti da Castro in quegli
anni supera i 100.000 milioni di dollari, una cifra di molto superiore
a quella stanziata dagli Usa per il Piano Marshall. Quando cadde
il muro di Berlino io tornai a l’Avana dove l’ambasciatore
russo mi disse: “D’ora in poi non scuciremo più
un soldo”. Così scoppiò la crisi, non per l’embargo
americano, sistematicamente aggirato grazie al Brasile e al Venezuela.
Così nel 1990 Cuba per denutrizione fu colpita da una deficienza
di vitamina A che provocò un’epidemia di malattie oftalmiche.
Nel 1993 quando i cubani erano ridotti all’acqua e zucchero,
la carenza di vitamina B provocò neuriti ottiche e periferiche
in 60 mila cubani.
Tutte queste, per gli aficionados, sono calunnie.
Cuba è un piccolo paradiso minacciato dagli americani. Centinaia
di cittadini, ogni anno, entrano in carcere per non aver condiviso
sul castrismo il giudizio degli estimatori occidentali. I diritti
umani restano un lusso, laggiù. E da noi, un elemento di
rimorso, quasi sempre travolto dagli interessi politici ed economici.
E poi, qualsiasi condanna turberebbe “la pace”, in nome
della quale siamo disposti a qualsiasi aberrazione. Per Castro,
invece, habrà tempo sufficiente para aplastar las cucharacias,
“ci sarà sempre tempo per calpestare gli scarafaggi”,
quelli cioè che non ne possono più del suo regime
di repressione e tentano di dirlo, finendo in galera.