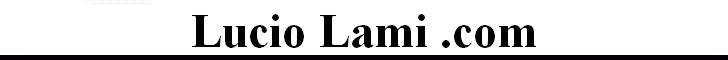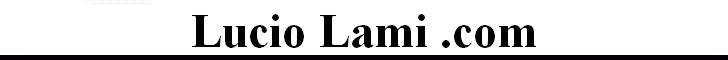» I libri »
Isbuscenskij, l'ultima carica «
Isbuscenskij, l'ultima carica
(Di seguito si propongono la prefazione dell'autore
e il capitolo dodicesimo)
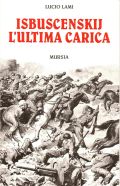 Nell'autunno
del 1960 stavo terminando il mio regolare servizio militare, in
«Savoia Cavalleria», a Merano, come sottotenente di
complemento, quando accadde un fatto che mise in subbuglio tutto
il Reggimento: Albino si ammalò. Albino era l'ultimo cavallo
superstite della carica di Isbuscenskij, una specie di istituzione.
Viveva in un box tutto suo, all'ombra dei carri armati, e gli
teneva compagnia Mariolino, un asinello allegro e lavativo che
dava segni di insofferenza solo quando il maresciallo di scuderia
lo costringeva a spianare la sabbia del galoppatoio.
Nell'autunno
del 1960 stavo terminando il mio regolare servizio militare, in
«Savoia Cavalleria», a Merano, come sottotenente di
complemento, quando accadde un fatto che mise in subbuglio tutto
il Reggimento: Albino si ammalò. Albino era l'ultimo cavallo
superstite della carica di Isbuscenskij, una specie di istituzione.
Viveva in un box tutto suo, all'ombra dei carri armati, e gli
teneva compagnia Mariolino, un asinello allegro e lavativo che
dava segni di insofferenza solo quando il maresciallo di scuderia
lo costringeva a spianare la sabbia del galoppatoio.
Ricordo che mi informavo di Albino quasi ogni
mattina, quando uscivo con Omar per la passeggiata sotto i meli
di Maia Bassa. Avevo dovuto ricorrere a mille astuzie per poter
montare uno dei pochissimi cavalli rimasti alla scuderia ufficiali.
Era infatti quello il tempo in cui, a colpi di circolare, il ministero
stava freneticamente sloggiando dalle caserme di cavalleria gli
ultimi quadrupedi sopravvissuti all'arrivo dei carri, con una
serie di provvedimenti che contribuirono a far tramontare definitivamente
la grande tradizione di Pinerolo, prima che potesse essere trapiantata
nelle scuole non militari. [1]
Lo scalpitare di un cavallo destava ormai curiosità
anche nei «cavalieri», per i quali era quasi un avvenimento
vedere il vicecomandante uscire in passeggiata sul suo grigio,
o qualche subalterno lavorare in maneggio ad ore impossibili,
o il capitano Grignolo, olimpionico di complemento, di passaggio
dopo qualche gara, fare una ripresina dimostrativa, prima di riprendere
la via di Passo Corese.
La malattia di Albino, quindi, rappresentava per
tutti una pena nella pena, quasi un accanimento della sorte. La
povera bestia non dava segno di soffrire; anzi, come si conveniva
a un cavallo da guerra, teneva un atteggiamento dignitoso e, con
l'unico occhio sano, guardava pacatamente il veterinario che la
curava: un veterinario che, per colmo di ironia, apparteneva al
vicino reggimento di artiglieria da montagna, era avvezzo a trattar
con i muli, e gli ronzava attorno sventolandogli sotto il naso
la penna del cappello alpino. A detta del veterinario la diagnosi
era chiara: vecchiaia. Albino, più che soffrire di un malanno
preciso, era soggetto ai mille acciacchi, propri di quei vecchi
che in gioventù non si sono risparmiati. E lui, il reduce
di Isbuscenskij, aveva fatto il galletto fino all'ultimo. Ricordo
che, solo un paio di mesi prima, durante le prove per la festa
del Reggimento, si era esibito in una delle sue imprese: quando
il trombettiere, al momento della commemorazione dei caduti, aveva
suonato la carica, Albino era stato improvvisamente colto da un
fremito e, piantato in asso l'inesperto palafreniere, era partito
al galoppo traversando tutta la piazza d'armi e andandosi a infilare
sotto gli enormi capannoni dove erano custoditi i nuovi Patton.
Fu, quella, la sua ultima sgroppata: il 21 ottobre, in barba alle
punture del veterinario-artigliere, Albino morì e fu subito
portato via per essere imbalsamato. Il suo box rimase vuoto, intatto,
con le pareti coperte delle foto del sergente maggiore Fantini
(morto nella carica, in sella ad Albino) e delle letterine che
gli scolari milanesi avevano scritto al celebre cavallo, nel primo
dopoguerra, quando il Reggimento, sospettato d'eresia e privato
del suo nome, era stato spedito in Alto Adige. [2]
Mariolino fu preso da una tremenda crisi depressiva
e fu trasferito nella scuderia degli altri cavalli. Il colonnello
Luigi Mirelli di Teora, 62° comandante del Reggimento, fece
stampare una partecipazione di lutto e la spedi agli amici. I
giornalisti arrivarono a frotte e ad essi qualche anziano ufficiale
raccontò la storia di Albino, con tutte le inesattezze
ormai entrate nella leggenda (compresa quella secondo la quale
il cavallo era stato ferito in guerra oltre che a una gamba, a
un occhio, mentre quel’occhio era stato sempre malato),
epurandola tuttavia di alcuni particolari, come quello riguardante
il servizio prestato da Albino, «sequestrato», nella
Repubblica di Salò; particolare che avrebbe permesso a
qualche rappresentante della stampa di attribuire alla povera
bestia un passato fascista del quale in realtà non era
responsabile.
Fu proprio per cercare del materiale da fornire
a un giornalista (oggi caro amico e collega), che cominciai a
rovistare tra le vecchie carte conservate nella sala ricordi del
Circolo Ufficiali. Così, scartabellando con pazienza, mi
resi conto di tre fatti che ignoravo:
1°) nessuno aveva mai scritto una cronaca precisa dell’ultima
carica, neppure coloro che avevano redatto le relazioni ufficiali
[3] per l'ufficio storico;
2°) al di là del!' episodio eroico della carica, c'era
tutta un'odissea da riscoprire: la lunga marcia del Reggimento
dalla Jugoslavia al Don e la sua presenza nello sfortunato Corpo
di Spedizione, buttato allo sbaraglio nelle steppe russe;
3°) con la carica di Isbuscenskij si concludeva, dopo cinquemila
anni, la storia del combattimento a cavallo e soprattutto, per
l'Italia, finiva il periodo dei combattimenti ottocenteschi, romantici
e savoiardi innestati sulla tradizione delle guerre d'Indipendenza.
1. - I documenti sulla carica erano pochi e scarsamente
attendibili. Le relazioni ufficiali, ad esempio, ostinandosi a
sostenere che la divisione «Sforzesca» non cedette,
ma «si ritirò ordinatamente», falsano ancor
oggi la realtà dei fatti e sminuiscono involontariamente
anche il valore della carica che, invece, servi proprio ad alleggerire
la pressione nella zona in cui i russi stavano dilagando e, bloccando
un'ala dello schieramento avversario, salvò probabilmente
la vita a migliaia di sbandati.
I resoconti della stampa dell'epoca erano, invece,
ampollosi e spesso imprecisi, tanto che i reduci non perdonarono
mai ai giornalisti le corrispondenze di quel tempo. [4]
A loro volta, i superstiti, rientrati in Italia nel momento dei
grandi sconvolgimenti politici, si chiusero in un pudico riserbo
che è ancor oggi difficile violare. Solo qualcuno pubblicò
brevi scritti, sulla traccia dei ricordi personali; [5]
qualche altro, consultato come esperto, ma non essendo stato protagonista
dell'avvenimento (pur essendo col Reggimento, in Russia) fini
col riportare notizie orecchiate, che spesso si sono dimostrate
inesatte. Infine, un lungo racconto romanzato intitolato La
carica senza ritorno fu scritto, con il beneplacito di Bettoni,
nel 1943 (da un autore del quale non mi è stato possibile
scoprire l'identità) e fu stampato, nel mese di luglio
dello stesso anno, nella collana «Eroi e avventure della
nostra guerra», diretta da Leo Longanesi ed edita da Rizzoli.
La tiratura completa dell'opera stava per lasciare lo stabilimento
tipografico «Novissima» di Roma quando, la mattina
del 19 luglio 1943, avvenne il primo bombardamento aereo americano
sulla capitale che distrusse tra l'altro la tipografia e con essa
l'intera tiratura fresca di stampa. Una copia del manoscritto
(che, essendo romanzato, ha ormai solo il valore di un cimelio)
è conservata presso il Reggimento.
Un discorso a parte va fatto per il materiale fotografico.
L'Istituto «Luce», nel settembre del 1942, spedì
una troupe nella zona dove si trovava il «Savoia»
e il Reggimento dovette organizzare, sotto gli occhi del comandante
di divisione, una carica fasulla ad uso dei cineasti. Quelle immagini,
riprese dalle angolazioni più suggestive, a volte perfino
frontalmente, sono apparse ormai su riviste, libri ed enciclopedie
e sono state contrabbandate, spesso in buona fede, come autentiche.
In realtà non esistono altre foto della carica se non quelle
scattate, molto da lontano, da Abba. Abba morì combattendo,
con la macchina fotografica a tracolla. Il sottotenente Compagnoni
conservò l'apparecchio e lo riconsegnò alla madre
del caduto che però gliene fece dono. I rullini, sviluppati
dopo qualche tempo, sono stati tenuti nascosti fino ad ora nel
timore che si riaccendesse attorno al nome di Abba una polemica
inutile della quale parlo al capitolo dodicesimo.
Tutti questi particolari spiegano perché
io abbia sentito il bisogno di rintracciare i reduci della carica
e di ottenere da costoro i diari manoscritti, che molti avevano
conservato, il materiale fotografico inedito e preziosissimo che
era loro rimasto e una serie di interviste che ho registrato su
nastro e che spesso, nel libro, cito fedelmente.
2. - Tutto ciò che avvenne prima della carica
ha, storicamente, un valore eguale e forse superiore a quello
dello stesso episodio di Isbuscenskij. Gli studi del dopoguerra
(anche quelli stranieri, meno faziosi dei nostri) hanno dimostrato
abbondantemente come l'invio del CSIR fu una follia sia dal punto
di vista militare che da quello politico-economico. L'immissione
di due reggimenti di cavalleria nel CSIR non mutò di molto
la situazione. La cavalleria italiana, per alcuni aspetti, si
era dimostrata anacronistica già al tempo della Prima guerra
mondiale (nonostante il suo largo impiego e il contributo da essa
pagato) e tuttavia continuò a prepararsi, fino al 1940,
in base a criteri spesso arretrati che prevedevano, tra l'altro,
un impiego d'urto come dimostra la massima del maresciallo di
Sassonia, citata nei libri di testo dell'Accademia di Modena:
«Un reggimento di cavalleria è buono quando sa caricare
di carriera mille metri senza perdere l'allineamento». [6]
Questi anacronismi, va detto per amore di verità,
non erano solo nostri. Scrive il generale russo Aleksandr Vasil'jevic
Gorbatov: «Il 22 giugno (1942) fui nominato ispettore della
cavalleria presso il quartier generale delle linee sud-occidentali.
Non posso dire che quella nomina mi facesse piacere. Avevo prestato
servizio per ventotto anni in cavalleria, amavo quell’arma
più di qualsiasi arma, ma con la comparsa dell'aviazione
e dei carri armati, fin dal 1935 avevo cominciato a dubitare della
funzione che la cavalleria avrebbe avuto nella guerra futura,
specialmente sul teatro d'operazione occidentale». [7]
Anche da noi qualcuno aveva dubitato, ma le polemiche
subito accese si erano risolte a favore di chi non amava i cambiamenti.
I difensori non potevano concepire la trasformazione di un'arma
cosi gloriosa, tanto è vero che continuarono a battersi
anche dopo la campagna di Russia: «Alla luce della recente
esperienza» leggo infatti su una rivista militare del 1943
«si auspica che in futuro la cavalleria venga dotata di
una sciabola più pesante, con il centro di gravità
spostato in avanti». [8]
Nonostante tutte queste tare, la cavalleria italiana poté
assumere, in Russia, un ruolo di primo piano, nell'ambito del
nostro Corpo di Spedizione, quando si verificarono due situazioni
impreviste: il fallimento del piano tedesco mirante a stroncare
la Russia prima dell'inverno del 1941 (e il conseguente impantanamento
delle armate corazzate nel fango della steppa) e la crisi improvvisa
della produzione bellica sovietica. Quando le Panzerdivisionen
furono bloccate dal maltempo, e con esse le fanterie, si scopri
improvvisamente che i metodi di guerra facevano un balzo indietro
di almeno cento anni e che solo la cavalleria poteva proseguire
la marcia incurante del fango. E quando i russi contrattaccarono
sul Don e furono costretti a farlo senza l'appoggio di quei carri
armati di cui tanto scarseggiavano, allora la nostra cavalleria,
posta di fronte alle fanterie nemiche, poté caricare, sciabola
alla mano, come ai tempi di Balaklava.
3. - La carica di Isbuscenskij, come gran parte
delle azioni che la precedettero, fu senza dubbio un capitolo
di guerra di sapore ottocentesco ed è alla luce di questa
considerazione, credo, che Messe la definì «un episodio
di epica bellezza» [9], così come
un ufficiale dello Stato Maggiore francese aveva definito «spettacolo
sublime» la carica di Balaklava. Rispondeva ad esigenze
«ottocentesche» già il primo provvedimento
preso dal generale Barbò quando riunì i reggimenti
a cavallo in un unico raggruppamento, svincolato dalla fanteria
e dai reparti corazzati; già Napoleone aveva scritto: «Il
metodo di mescolare reparti di fanteria e di cavalleria è
sbagliato e non se ne ricavano che inconvenienti: la cavalleria
cessa di essere mobile, è impacciata nei suoi movimenti,
perde l'impulso, mentre la fanteria è compromessa e al
primo movimento della cavalleria si trova allo scoperto».
[10] Ottocentesca fu pure tutta la carica nella
sua incredibile spettacolarità: quando ebbe inizio, essa
fu condotta dal solo secondo squadrone e il Reggimento rispettò
cosi la vecchia regola di uno dei più grandi teorici della
cavalleria (Nolau): «Non fate mai caricare tutto il Reggimento:
una buona riserva può risolvere l'esito al momento della
mischia». Regola antica, già adottata da Annibale
a Canne; da Cromwell a Marston Moor (1644) e a Naseby (1645);
da Seydlitz, braccio destro di Federico II di Prussia, a Zorndorf
(1758).
Il fatto che la carica di Isbuscenskij sia nata
da un gesto di corale spontaneità e che sia stata condotta,
spesso, all'insegna dell'iniziativa personale, non toglie nulla
al suo carattere di episodio leggendario. Ugualmente, nulla cambia
nell'epica del quadro, se anche vi si inserisce l'apparizione
delle tecniche più nuove (come il lancio di bombe a mano
da cavallo) adottate durante il combattimento.
In sostanza, la carica di Isbuscenskij, ultima
tradizionalmente della cavalleria montata, [11]
chiuse (sia pure con qualche decennio di imprevedibile ritardo)
un capitolo di storia che era cominciato tremila anni prima di
Cristo, con i primi scontri a cavallo fra le tribù dell'
Asia centrale. L'episodio acquista un sapore leggendario, incredibile,
quasi paradossale, specialmente se si tiene conto che avvenne
a una trentina di mesi dallo sganciamento della prima bomba atomica.
L. L.
Note
1 - Le conseguenze di quei provvedimenti
sono constatabili oggi: i D'Inzeo hanno pochissimi eredi e l'Italia,
che ha esportato in tutto il mondo il «metodo Caprilli»,
sembra destinata, nel campo equestre, a una faticosa rimonta.
La scomparsa degli allevamenti (come quello di Persano ad esempio)
ci costringe ad acquistare, a peso d'oro, cavalli all'estero.
Dalle scuole private esce ben poco: mancano istruttori qualificati
e lo sport attivo è praticato solo da chi può permettersi
di acquistare cavalli eccezionali, spesso destinati a sopportare
monte modeste. Di Pinerolo, università del cavallo, non
resta che un fumoso ricordo.
2 - Al Reggimento, ricostituito
nel dopoguerra, venne dato temporaneamente (nel 1950) il nome
di «Gorizia Cavalleria», con un provvedimento tragicomico
e antistorico. Il reparto fu poi trasferito (1957), dopo 46 anni
di vita milanese, a Merano, non tanto per motivi logistici quanto
per evitare - si disse allora da più parti - che al Circolo
Ufficiali potessero ancora radunarsi, come accadeva nell'anteguerra,
i più accesi monarchici di Milano.
3 – È sintomatico,
a tal proposito, il fatto che lo stesso generale Messe, per scrivere
alcuni articoli sulla carica, abbia attinto quasi esclusivamente
da un articolo del corrispondente di guerra tedesco Ernest Weist.
D'altra parte, fu proprio Messe a sostenere, forse per carità
di patria, che la «Sforzesca» si era «ritirata
in buon ordine», depauperando così la carica del
suo vero merito: quello di aver ritardato di 24 ore l'attacco
in forze di Tschebotarewskij e quindi la caccia agli sbandati.
4 - Il giornalista e scrittore
Max David, nel suo libro Gli italiani a cavallo, scrive: «
... proprio a me Bettoni non cessava mai di rimproverare la cronaca
di Isbuscenskij che avevo inviata al mio giornale trovandomi in
Russia quale corrispondente di guerra. Bettoni diceva che, a parte
le inesattezze, la mia cronaca era stata ampollosa, gonfia, barocca,
oleografica. Me ne diceva di tutti i colori e se ne ricordava
sempre. Una volta che Bettoni montava Litargirio e lavoravamo
insieme a cavallo, nel campo di Villa Borghese, eravamo tornati
per caso sul discorso di Isbuscenskij, e Bettoni aveva fatto:
“Ah, quella tua cronaca dalla Russia, basta, basta, meglio
non parlarne". Invece me ne avrebbe riparlato non so mai
quante volte in quell'anno, che fu l'ultimo della sua vita».
5 - Tra questi va segnalato il
giornalista Luigi Gianoli, sottotenente in «Savoia»
durante la campagna di Russia. Gianoli ha scritto un racconto
(v. bibliografia), da me più volte citato, nel quale commenta
alcune pagine di un lungo diario di guerra. La narrazione, scritta
in forma impeccabile, alterna brani tratti dal diario a lunghi
periodi di commento, scritti in epoca successiva, nei quali spiccano,
oltre ad acute osservazioni di carattere generale, giudizi pungenti,
su uomini e fatti, che sono stati causa di malcelate reazioni
da parte degli altri reduci. A Gianoli va tuttavia riconosciuto,
tra gli altri, il merito di aver ricostruito alla perfezione un
certo clima decadente, tipico dell'arma «nobile»,
che riaffiora spesso tra le righe. Ecco un esempio: «Per
molti di noi la dichiarazione di guerra giunse addirittura come
una pugnalata alla dolce e accarezzata anglofilia. Perché
agli inglesi, se non altro per affinità di sentimenti ippici,
ci sentivamo tutti legati. E come potevamo protestare? Fumando
la pipa, acquistando e usando certi frustini che Pariani diceva
di trafugare ancora da Londra, bevendo whisky, continuando ad
agire come gente destinata a magnifiche parti in elevate tragedie,
convinti che i nostri gesti, le nostre battute esigessero attenzione,
rispetto, ammirazione».
6 - Cfr. Carlo Decristoforis,
Che cosa sia la guerra, E. Sarasino, 1894, p.146.
7 - Cfr. Gorbatov, Anni e guerre,
Bietti, 1965, p. 327.
8 - Cfr. «Rivista di Cavalleria»,
1943, n. 1.
9 - I giudizi dei militari nascono
quasi sempre da considerazioni tecniche. II politico e lo storico
giudicano ovviamente da un altro punto di vista. Così ha
fatto recentemente Giorgio Bocca (v. bibliografia), che ha impugnato
la definizione di Messe sostituendola con quella di «inutile
carneficina». In realtà, la carica fu inutile solo
se considerata nell'ambito di una guerra inutile. In questo senso,
anzi, fu drammatica. Di per se stessa, però, servi a salvare
un buon numero di sbandati della «Sforzesca» e degli
uomini in armi presso Tschebotarewskij. Inoltre, considerando
la proporzione delle forze, non fu neppure una carneficina: 39
morti in uno scontro tra seicento uomini contro duemila avversari.
Il basso numero delle perdite è sempre stato un dato caratteristico
delle cariche ben eseguite.
10 – Napoleone, Campagne
de Turenne (citata da Decristoforis). Le intenzioni di Barbò,
in realtà, non erano solo strategiche, come si vedrà
più avanti.
11 - Sin dalla fine della Seconda
guerra mondiale, quella di Isbuscenskij fu considerata l'ultima
carica di cavalleria della storia. Essa in effetti fu l'ultima
azione risolutrice condotta, a cavallo, e con grande successo
contro truppe regolari. Per rispetto alla cronologia va tuttavia
ricordato il combattimento di Poloj (Croazia) avvenuto il 17 ottobre
1942. In quell'occasione, il reggimento «Cavalleggeri di
Alessandria», che stava rientrando con una sezione del 1/23°
reggimento artiglieria dai mulini di D. Karasi (sul fiume Korana),
fu attaccato da formazioni partigiane ed accerchiato. Per aprirsi
un varco, il reggimento caricò ripetutamente, a interi
reparti. In una di queste cariche, effettuata dallo squadrone,
dallo squadrone mitraglieri e dallo squadrone comando fu in testa
lo stesso comandante, colonnello Aimone Cat, con al fianco l'alfiere
e lo stendardo. Le perdite furono gravissime. Tra i decorati va
ricordato il capitano Antonio Vinaccia M.O.V.M. (Cfr. Relazione
ufficiale inviata al comando della divisione Celere «Eugenio
di Savoia»).
Capitolo dodicesimo
Caricat, Savoia!
La mattina del 24 agosto la pattuglia del sergente
Comolli uscì, com'era stato stabilito, alle 3 e 30 dopo
aver dato ai cavalli un po' di biada ed aver cercato invano dell'acqua
con cui abbeverarli. L'aria era ancora fredda e gli uomini del
Reggimento dormivano avvolti nei pastrani, il capo protetto dal
passamontagna. Nel crepuscolo mattutino si intravedeva a malapena
la sagoma morbida di quota 213,5 ed il suo dolce declinare verso
il Don. Accompagnata da un leggero tintinnare di ferri, la pattuglia
superò la linea dei mitraglieri e infine quella delle sentinelle
alle quali il caporal maggiore Bottini raccomandò: «Non
sparateci addosso, quando torniamo: rientreremo di qui ».
I cavalli presero a trottare leggeri tra i campi
di girasoli e i morbidi tappeti sui quali il grano era stato mietuto
da poco: c'era una nebbiolina lattiginosa che rendeva il paesaggio
quasi irreale. In testa alla pattuglia marciava Bottini, guastatore,
seguito dal caporale Legnani e dall'appuntato Petroso; gli altri
tre uomini, guidati da Comolli, procedevano a un centinaio di
metri, armi alla mano.
«Dopo un paio di chilometri, vedemmo, dall'alto
di una balka, quel carro agricolo di cui si era tanto
parlato la sera precedente: Legnani parti allora al galoppo e,
dopo aver fatto un ampio giro, sbucò all'improvviso alle
spalle del carro da dove ci fece segno, agitando un braccio, che
non c'era nulla di cui preoccuparsi. Noi gli segnalammo di rientrare.
«Era appena tornato da noi quando, a una
cinquantina di metri, vidi qualche cosa che si muoveva e luccicava
in mezzo a un campo di girasoli: sembrava un elmetto. "Forse
è la pattuglia tedesca che ci viene incontro», dissi,
e sollevatomi in piedi sulle staffe gridai: "Ehi, camarade!".
Ma non udimmo risposta. Allora accesi una sigaretta e mi avviai
tra i girasoli, verso il centro del campo. Ero a una ventina di
metri quando l'elmetto riaffiorò, e, questa volta, lo vidi
bene: era color oliva con al centro una stella rossa.
«Ricordo che in quel momento, forse a causa
della paura, riuscii a fare, in una frazione di secondo, una intera
serie di considerazioni: montavo una cavalla ombrosa ed ero armato
con un parabellum russo: se avessi sparato a raffica la cavalla
mi avrebbe quasi sicuramente disarcionato; accanto a me, invece,
c'era Petroso che montava Olwo, il cavallo più tranquillo
del Reggimento...
«Quasi istintivamente gridai: "Spara
tu, Petroso, spara!".
Petroso, da buon siciliano, non si scompose: teneva il moschetto
sotto il braccio e lasciò partire un colpo che colpi il
russo proprio al centro della fronte, un dito sotto il filo dell'elmetto.
«Fu come un segnale: si scatenò l'inferno.
Mai visto un dietrofront rapido come il nostro né cavalli
cosi veloci. Galoppammo alla disperata per alcuni minuti mentre
le mitragliatrici sparavano tanto che vedevo la terra ribollire
per i colpi, tra le gambe dei cavalli. Uno di questi, Trabocco,
venne colpito mortalmente e Galbusera, che lo montava, invece
di cadere con lui, si esibì in una specie di salto mortale
e continuò la fuga a piedi, senza perdere un istante, mentre
i russi cominciavano a tirarci addosso anche con i mortai. Fu
a quel punto che dal Reggimento, nonostante le nostre raccomandazioni,
partirono alcune raffiche di mitragliatrice, fortunatamente alte,
sparate da qualcuno che ci aveva preso per cosacchi». [1]
Al Reggimento dormivano quasi tutti: solo qualche
gruppetto di soldati stava rigovernando i cavalli o sorbendo il
caffè; la sveglia venne data dalle prime raffiche e soprattutto
dalle esplosioni dei colpi di mortaio che fortunatamente cadevano
lontano dal quadrato. Gli ufficiali saltarono giù dalle
loro brandine o dai camion sui quali dormivano, i soldati si alzarono
rapidamente da terra e, raccolte le loro cose, corsero a recuperare
i cavalli, Bettoni raggiunse la radio e diede a Ferruccio Marino
un messaggio per la brigata. Banfi, seconda cuffia, si affrettò
a portare un elmetto al collega ed a cacciarglielo in testa, ma
in quel preciso momento una raffica arrivò sibilando ed
una pallottola lo colse al ventre. Marino, mentre trasmetteva,
guardò impotente il suo amico accartocciarsi al suolo,
invocando la mamma. [2]
I mitraglieri, intanto, avevano cominciato a rispondere
al fuoco e sgranavano caricatori mentre il maggiore Albini e il
capitano Solaroli di Briona, delle batterie a cavallo, avevano
messo in azione i loro soldati. La fronte del nemico veniva rivelata,
alla tenue luce dell'alba, dalle fiammelle azzurrognole delle
armi automatiche: era ampia circa un chilometro e non distava,
ormai, più di ottocento metri. I russi erano arrivati durante
la notte, forse avevano sentito i rumori e le voci provenienti
dalla zona dove sostava il «Savoia» e si erano preparati,
scavando buche e schierandosi a semicerchio, a sferrare l'attacco
al mattino. Era stato probabilmente per non rinunciare alla sorpresa
che non avevano aperto il fuoco, per primi, sulla pattuglia esplorante.
Ora però le loro intenzioni erano chiare. Il nemico, infatti,
forte di duemila uomini (due battaglioni di siberiani) [3]
contro settecento e in vantaggio per la posizione favorevole che
occupava, poteva essere sicuro del successo.
Bettoni non ebbe dubbi, pensò di attaccare
e comunicò la sua decisione a Conforti. [4]
Questi si rivolse a De Leone: «Attaccare con decisione il
fianco sinistro della linea nemica». De Leone era pallido
d'orgasmo: saltò a cavallo e raggiunse i suoi; chiamò
Donadelli, Gotta, Bonavera e il giovane Bruni, che comandava il
plotone mitraglieri aggregato allo squadrone, e diede loro poche
disposizioni. Nell'aria schioccò un ordine: «Secondo
squadrone a cavallo!». E ancora: «A frotte, avanti:
Trottooo!». Lo squadrone usci rombando dal quadrato, descrisse
un ampio semicerchio sulla destra e si infilò in un canalone
naturale che lo defilava al tiro nemico. «Quando udimmo
gridare "Sciabl-man!" fu chiaro per tutti che cosa ci
attendeva». [5] Dal comando di Reggimento
videro allontanarsi ondeggiando quella lunga scia: gli elmetti
luccicanti, le groppe tonde dei cavalli, le trombe d'ottone e
le bandoliere ballonzolanti sulle schiene ricurve.
Il neo-promosso maggiore Manusardi guardò
quella scena quasi con rabbia: lo squadrone, che fino a pochi
giorni prima era stato suo, andava a caricare. A lui, invece,
toccava di stare lì, «addetto al comando» e
appiedato, visto che l'ultimo cavallo gliel'avevano ucciso due
giorni prima. Ad un tratto sentì di non poter resistere:
«Datemi un cavallo!» gridò. Gli corse incontro
Casanova reggendo per le briglie il magnifico Bergolo: «Ci
sarebbe questo» disse il maresciallo «ma è
del generale Barbò...». Manusardi non gli diede neppure
retta: saltò in volteggio, con l'agilità di un ragazzo,
e diede di sprone. Raggiunse lo squadrone nell'avvallamento e
affiancatosi a De Leone gli disse: «Vengo con te, come tuo
gregario».
«Il nostro vecchio capitano è con noi!» gridò
allora De Leone e nei suoi soldati crebbe l'eccitazione. [6]
Lo squadrone riaffiorò all'improvviso dal
leggero avvallamento vicinissimo al fianco sinistro del nemico:
un attimo d'attesa, poi: «Galoppooo!». E subito dopo:
«Caricaaat!», un grido al quale rispose un coro fragoroso:
«Savoia!»; il boato coprì il frastuono della
carica e giunse nitido fino al Reggimento. Il galoppo divenne
allora carriera sfrenata e i plotoni irruppero come un fiume straripante
sulle linee nemiche gridando, sciabolando, sparando, lanciando
bombe a mano. I cavalli sembravano guariti dalla fatica e rampavano
schiumanti, saltando trincee e nidi di mitragliatrici, cacciandosi
a frotte verso l'obiettivo indicato dallo sprone e scomparendo
entro enormi nubi di polvere, seguiti dal tuono del loro zoccolio
e dal crepitare furioso delle armi.
Molti venivano colpiti e dalle loro ferite, per
centinaia di metri, zampillava il sangue vermiglio ad ogni tempo
di galoppo. «Sembrava incredibile, ma c'erano cavalli già
morti che continuavano a galoppare come fantasmi schiantandosi
poi al suolo, di colpo, come querce colpite dalla folgore».
[7]
Sulla fronte, intanto, arrivava ancora qualche
colpo dalle batterie italiane che avevano voluto tenere il nemico
sotto il fuoco fino agli ultimi istanti: un'esplosione avvenne
nel bel mezzo di un plotone e molti cavalli saltarono in aria.
«Il trombettiere Carenzi nell'armeggiare con la tromba e
la pistola si lasciò sfuggire. un colpo che centrò
la testa del cavallo facendolo stramazzare al suolo». [8]
Una raffica feri subito anche Ziguni, e il capitano
De Leone, che lo montava, rovinò a terra gridando: «Datemi
un altro cavallo!». L'attendente accorse per cedergli Zolbata,
ma la bestia, l'occhio infuocato e le froge dilatate, cominciò
a rampare e, liberatasi, riprese la sua corsa pazza, facendo sobbalzare
le staffe vuote sui fianchi martoriati. Allora De Leone raccolse
un'arma e disse all'attendente: «Prima consumeremo tutte
le munizioni, poi ci ammazzeremo piuttosto che darci prigionieri».
«Come comanda lei, signor capitano» rispose il soldato.
[9]
Caduto il comandante, gli uomini cominciarono pericolosamente
a perdere la direzione, ma in quel momento la voce tagliente di
Manusardi sovrastò ogni rumore: «Non sbandate, seguitemi!».
Manusardi prendeva il comando così, mentre caricava, il
capo coperto della sola bustina e nella mano il frustino, come
nel bel mezzo di una esercitazione.
Cessato l'appoggio dell'artiglieria, i russi sbucarono
dai loro rifugi e opposero una resistenza crescente: una delle
prime raffiche falciò Pastorello e Dalmini: arrivò
di traverso e colpi il primo alla testa e al torace e il secondo
all'addome: i due scivolarono di sella mentre i loro cavalli continuavano
la corsa come impazziti. Lo squadrone stava caricando nel mezzo
dello schieramento nemico, ma i russi delle prime posizioni, non
ancora impegnati frontalmente, si voltavano spesso per colpire
i cavalieri alle spalle.
La carica stava così dando luogo a mille
episodi. Il caporale Lolli, non essendo riuscito ad estrarre la
sciabola (vi aveva legato il secchiello dell'acqua e si era ghiacciata
nel fodero), caricava tenendo alta una bomba a mano; quando vide
un russo che lo attendeva a piè fermo, baionetta puntata,
fece scartare il cavallo e lanciò la bomba: l'avversario
fu dilaniato. Un russo, che aveva assistito alla scena, lasciò
partire una raffica: Erbaccia rovinò al suolo e Lolli senti
una gamba ricoprirsi di sangue. Sopraggiungeva intanto Valsecchi
sciabolando alcuni russi in fuga: Lolli lo chiamò e l'amico
scese ad aiutarlo, fermò un cavallo che passava senza cavaliere
(era Diavoletto) e rimise in sella l'amico. La situazione precipitava:
a mano a mano che lo squadrone procedeva galoppando, le sue file
si assottigliavano; ad ogni raffica si vedevano cavalli impennarsi
o ruzzolare, cavalieri piegarsi sul collo o cadere all'indietro,
scivolare dall'animale, restando talvolta impigliati in una staffa,
trascinati nella polvere.
I superstiti raddoppiavano la foga: molti di loro
mulinavano sciabole cosacche, preda di guerra, armi terribili,
senza guardia, strettamente legate al polso e pesantissime, che
scendevano come spade medievali sugli elmetti, spappolandoli in
un sol colpo assieme alla testa che riparavano. Il frastuono era
tremendo anche perché dalle trincee dei russi erano improvvisamente
sbucati gruppi di donne che urlavano «Urrà Stalin!»
in continuazione, quasi istericamente, eccitando i soldati.
Ad un tratto, una raffica di parabellum colpi in
pieno petto Fusinato il cui cavallo, dopo un'impennata, si lanciò
verso le linee nemiche attraverso un campo di girasoli quasi fosse
attirato da un misterioso richiamo. In coda alla turba dei cavalieri
procedeva, un po' distaccato, Malingambi. Il suo ritardo era dovuto
al fatto che Quota, una cavalla scartata da Toja, era chiaramente
miope e incespicava ad ogni ostacolo. Ad un tratto, un russo usci
a mezza cintola da una buca e lasciò partire una raffica
che sibilò sopra la schiena di Malingambi e ammazzò
il soldato che galoppava davanti a lui. Allora Malingambi diede
uno strattone a Quota che galoppò ignara sulla buca mentre
il suo cavaliere calava un terribile fendente sull'avversario
che era senza elmetto: la testa del soldato si apri, scoppiando
come un melagrana, mentre una raffica partiva da lì vicino
e questa volta coglieva Malingambi trapassandogli una gamba.
Lo squadrone aveva intanto superato di poco la
metà della fronte nemica, ma la sua forza era ridotta ormai
a meno della metà degli effettivi. Resosene conto, Manusardi
diede l'alt e, sotto il fuoco nemico, chiamò a sé
la cinquantina di superstiti e disse loro: «Torniamo indietro
e carichiamo un'altra volta: andiamo a liberare il vostro capitano».
Gli uomini ripartirono aprendosi la strada con le bombe a mano.
Ora l'azione avrebbe avuto maggiore efficacia perché
si sentiva sparare in direzione del Reggimento, segno evidente
che stavano sopraggiungendo rinforzi.
Al comando, da alcuni minuti, ci si era resi conto
della situazione critica: gli ufficiali, seguendo l'azione col
binocolo, avevano notato che molti cavalieri venivano colpiti
alle spalle dai russi della prima linea. Abba, a un certo punto,
aveva gridato: «Li stanno ammazzando tutti: bisogna impegnare
i russi anche frontalmente». Bettoni, che era giunto alla
stessa conclusione, gli rispose: «Vai su tu, col quarto
appiedato».
Rapidamente fu adunato lo squadrone, sostituito qualche appuntato
ai cavalli in circolo, e affidato un compito di copertura ai mitraglieri
di Foresio. Poi i plotoni si disseminarono nella pianura avanzando
rapidamente: Abba al centro con la squadra comando, Rubino dietro
di lui col plotone di riserva, Compagnoni sulla sinistra e Toja
a destra.
C'era da percorrere quasi mezzo chilometro per
giungere sul nemico e il capitano Abba ne approfittò per
scattare alcune foto con l'apparecchio che teneva sempre al collo:
all'orizzonte era ben visibile il pennacchio di polvere sollevato
da quelli del 2° squadrone che, a quel punto dell'azione,
stavano terminando la prima carica. Ma ben presto non ci fu più
tempo per le foto: Compagnoni incontrò i primi russi nelle
buche e li fece sloggiare, a colpi di bombe a mano, mandando alcuni
prigionieri, sotto scorta, verso il comando.
Dopo aver attraversato un campo di girasoli ed
essere penetrati in uno di erba alta, quelli del 4° vennero
improvvisamente investiti dal fuoco delle mitragliatrici russe
e molti caddero feriti nel verde che li nascose alla vista. Abba
ordinò allora di fare allargare i plotoni e di procedere
strisciando. Rubino, che si trovava ancora dietro la squadra comando,
ricevette l'ordine di spostarsi sull'estrema sinistra dello schieramento.
«Si vedevano i russi scappare e voltarsi
di scatto per sparare. In un attimo di tregua un cavaliere della
squadra comando mi portò l'ordine di avanzare: ero vicino
a un ragazzo del mio plotone che, ferito a un ginocchio, non poteva
stare coricato ma io insistevo che stesse giù perché,
quando avevo provato ad alzarmi, un proiettile nemico mi aveva
forato la bustina». [10]
L'ordine di avanzare arrivò dunque a Rubino.
Il sottotenente balzò avanti, alzandosi in piedi, e una
raffica lo colse in pieno assieme a molti suoi uomini. Il giovane
ufficiale era stato colpito a una gamba, ma continuò ad
avanzare zoppicando, poi un'altra pallottola gli trapassò
un polmone e allora fu costretto a fermarsi ma, tamponandosi il
sangue alla meglio, continuò a dirigere l'azione del plotone
fino alla fine del combattimento. [11]
Lo squadrone si muoveva in un avvallamento e i
russi sfruttavano la loro posizione dominante sparando d'infilata
e riparandosi dietro un gruppo di macchine agricole abbandonate.
Solo Toja avanzava speditamente sulla sinistra cercando di raggiungere
una posizione più elevata dalla quale attaccare il nemico
sul fianco; spesso doveva moderare la foga dei suoi che non badavano
a risparmiarsi: Mannozzi, Camporese, Cioffi, Grattirola, Secchi
e Rizzi. Ad un tratto, Mannozzi, che aveva individuato un nido
di armi automatiche, vi si buttò sopra armato di bombe
a mano, ma una raffica lo centrò con tanta violenza da
farlo avvitare su se stesso e cadere a pochi passi dall'obiettivo.
Toja, che aveva assistito alla scena, agguantò un mitragliatore,
lo rivolse in quella direzione e continuò a sparare finché
non fu sicuro di aver ridotto al silenzio gli avversari. Abba,
intanto, che aveva capito le intenzioni di Toja, si avvicinò
per dargli aiuto sulla destra dello schieramento.
Fu a quel punto che si udirono distintamente quelli
del 2° che stavano concludendo la seconda carica. Dall'aspetto
dei cavalieri, la seconda passata non doveva essere stata meno
violenta della prima.
«A un tratto mi ero ritrovato solo, con un
gruppo di russi attorno: allora cominciai a urlare e a sciabolare
puntando briglia e speroni e facendo impennare il cavallo. Sentii
che in me si era scatenata la forza della sopravvivenza che mi
dava una incredibile lucidità nelle azioni. Caricavo e
sciabolavo nello spazio di pochi metri, urlando: "Daliéco,
daliéco" (lontano, via!). I russi allora si misero
a correre, come impazziti e senza sparare. Io li inseguivo al
galoppo frenato e loro correvano... ». [12]
Poco più a lato galoppava il tenente Gotta:
il suo Palù aveva il mantello grigio sforacchiato in più
punti e dai fori zampillava il sangue. Bruni vide la scena e gridò
al collega: «Attento, il cavallo ti muore sotto!».
Allora Gotta scese di sella e chiamò l'attendente, ma Palù
eccitato dalle ferite e dal fragore si liberò con uno strattone
e riprese la sua corsa furiosa, nel senso della carica, scomparendo
nel polverone.
Anche altri erano protagonisti di singolari episodi.
Calvi, ad esempio, che era rimasto ferito e appiedato (gli avevano
ucciso il cavallo), vide con disperazione i compagni rientrare,
senza accorgersi di lui; allora, in un estremo tentativo, fece
un fischio a un cavallo che vagava senza cavaliere e con grande
stupore vide la bestia volgersi verso di lui e raggiungerlo. Il
caporale Dirti, invece, dopo aver cambiato due cavalli, cadde
con l'ultimo senza riuscire a togliere un piede dalla staffa,
cosicché il cavallo gli rovinò sopra tenendolo prigioniero
col suo peso inerte. Dirti, allora, visti due sbandati russi,
puntò contro di loro l'arma e fece segno perché
accorressero a liberarlo; cosa che essi fecero prontamente.
Tra i primi a sbucare da quel polverone fu Manusardi:
era completamente coperto di sangue, ma non era ferito; il sangue
era di Bergolo che aveva il petto squarciato e che quasi subito
rovinò al suolo. Manusardi passò accanto a Abba
e ebbe appena il tempo di salutarlo (sarebbe stata l'ultima volta):
«Bravo, Abba: ti faccio mandare subito rinforzi».
Poi, l'ufficiale raggiunse a piedi il comando e, vedendo che i
rinforzi non erano ancora partiti, [13] gridò:
«Guardate che lassù non è ancora finito: occorre
un 'altro squadrone». Allora Bettoni diede disposizione
che il 3° caricasse. A quell'ordine Marchio fece impennare
il cavallo e parve preso da un'emozione incredibile. Raggiunse
i suoi e diede brevi disposizioni a Bussolera e a Scarpelli che
comandava i mitraglieri. Lo squadrone non aveva bisogno di incitamento
perché tutti erano pronti da tempo e sembravano fremere
d'impazienza. «Ricordo che vidi il sergente Fantini, tutto
agitato, in attesa di partire. Aveva in testa la bustina, alla
maniera di certi ufficiali, ed io gli dissi: "Ti dà
noia la salute? Mettiti l'elmetto e ricorda che a casa hai una
mamma anziana che ti aspetta", ma sembrava che non mi sentisse
». [14]
Gli ordini secchi tranciarono l'aria ancora una
volta e il fragore degli zoccoli si allontanò come un tuono,
lungo la pianura. Marchio, per paura di non arrivare a tempo,
non prese la precauzione di rifare il percorso del 2° squadrone,
ma puntò dritto verso la fronte.
Fu a quel punto che il maggiore Litta mandò
il suo aiutante, il tenente Ragazzi, per dire al colonnello che,
poiché tutto il suo gruppo stava caricando, anch'egli,
con gli addetti al comando di gruppo, intendeva caricare. Litta
non attese neppure la risposta e parti con la decina di uomini
che gli erano rimasti. [15] Ragazzi, nonostante
gli ordini contrari ricevuti, lo raggiunse galoppando e ingaggiò
con lui una vivace discussione, perché non voleva tornare
indietro. Persino gli addetti alla radio del comando di gruppo
si misero al trotto: il sergente Cavagni, il sergente Colla, i
cavalieri Fort e Regusa partirono trascinando il secondo cavallo
carico di basti e di apparecchiature. Il maresciallo Casanova,
nel vederli, corse a tagliare loro la strada imprecando: «Dove
volete andare, voi, con la radio, i basti e i cavalli a mano,
a farvi ammazzare?». I quattro si fermarono mugugnando.
Litta, a quel punto, era già in testa a tutti: «Ricordo
che, galoppando, trovò tempo di notare che alcuni caricavano
senza stecca nella bustina». [16]
Il 3° intanto era giunto nell'avvallamento
nel quale combattevano i colleghi del 4°. Lo squadrone, che
era stato raggiunto da Litta e da tutto il comando di gruppo,
arrivò in un punto di passaggio obbligato tra ampi scoscendimenti
provocati dall'erosione del terreno e dovette restringersi. Questo
movimento, però, fu fatale perché i russi, che avevano
sistemato sui lati mortai e mitragliatrici, aprirono un fuoco
infernale e centratissimo.
«Nel vederli arrivare ci eravamo un attimo
fermati per guardare sbalorditi quella carica tremenda, ma presto
il fuoco si abbatté su di loro con incredibile precisione:
vidi cadere per primo Ragazzi, poi il sergente Mentasti, poi Ardito,
l'attendente del maggiore, poi il sergente maggiore Fantini che
montava Albino, poi il sergente Bonacina e Dossena e tanti altri
cavalieri falciati come grano dalle raffiche. Vidi Marchio che,
insanguinato, urlava di dolore e di rabbia, e raccolsi Bussolera
ferito all'addome». [17] Anche Litta era
stato ferito a una gamba da una raffica che gli aveva ucciso il
cavallo: l'ufficiale cercò di salire su quello del suo
caporale, ma le forze gli mancarono. Allora si trascinò
verso una mitragliatrice e indicando al soldato un punto del fronte
disse: «Più a destra; devi tirare da quella parte».
«Signorsì», rispose il mitragliere che ormai
sparava piangendo come un bambino. Il maggiore avrebbe voluto
continuare a dare ordini, ma fu raggiunto da un'altra pallottola.
Un infermiere, Molteni, accorse e si rese subito
conto che non c'era più nulla da fare. Litta ebbe appena
il tempo di sussurrare: «Madonna santa, ti raccomando il
mio bambino». [18]
Marchio, intanto, era stato raggiunto da un cavaliere
che gli aveva preso il cavallo per le briglie. L'ufficiale, infatti,
aveva entrambe le braccia ferite (una spezzata da schegge di mortaio),
che gli ciondolavano dalle spalle ed era stato costretto a galoppare
reggendosi solo con le ginocchia.
Il 3° squadrone era ormai senza ufficiali (Scarpelli era appiedato
con i suoi mitraglieri) e fu il sergente Negri a guidare l'ultimo
balzo.
Appena il 3° ebbe sopravvanzato il 4°,
Abba decise di spostarsi sulla sinistra dove il plotone di Rubino
era rimasto senza ufficiale. Ma durante lo spostamento, una raffica
falciò lui e molti dei suoi uomini: lo raccolsero poco
dopo Toja e Compagnoni: «Aveva un forellino rosso all'altezza
del cuore e sulle labbra il suo inconfondibile sorriso».
[19]
Fu a quel punto che Bossi, il «solitario»,
spuntò da chissà dove e traversò di corsa
la fronte: teneva in una mano una mitragliatrice senza treppiede
e nell'altra una cassetta di munizioni. Trovato un punto sufficientemente
elevato dal quale si potessero prendere di mira i russi che mitragliavano,
standosene sotto una trebbiatrice, Bossi si gettò carponi,
infilò la canna dell'arma nel manico della cassetta perché
restasse più ferma e mirò. I russi, che si erano
accorti di lui, fecero le stesse operazioni: le raffiche partirono
dalle due armi quasi contemporaneamente, e, quasi contemporaneamente,
le due mitragliatrici tacquero per sempre.
Proprio in quel momento si udirono le grida di
vittoria lanciate dai superstiti del 3° squadrone che stavano
mettendo in fuga gli ultimi nemici: «Gli eravamo saltati
addosso sciabole alla mano ma quando ci accorgemmo che non bastava
usammo tutti le bombe a mano. Dell舗intero squadrone (più
di cento cavalieri) eravamo rimasti una trentina, ma li mettemmo
in fuga. Molti, feriti, si cacciavano nel campo di girasoli che
avevano alle spalle, ma i più si arrendevano. Dei nostri,
l'ultimo a morire fu Bianchi, un ragazzo di Magenta: gli spararono
contemporaneamente in tre, da una buca. lo li vidi e galoppai
su di loro gettando nella fossa una bomba a mano, ma la bomba
non esplose e allora fui costretto a voltare il cavallo e a tornare
indietro per lanciarne un'altra. Da parte russa le ultime a mollare
furono le donne: le "sorelle della misericordia", vista
la mala parata, si erano messe a sparare anche loro». [20]
Tra una raffica e l'altra, quelle donne coraggiose
non cessavano però di dare la loro assistenza ai feriti:
«Ne vidi una con il volto sfregiato da una sciabolata: girava
fra le trincee quando udì uno dei nostri, il caporal maggiore
Alessandrini, che invocava aiuto. Allora si fermò e chinatasi
sul ferito si mise ad assisterlo amorevolmente. Quando andammo
per raccoglierli, li trovammo morti, tutti e due, uno accanto
all'altra». [21]
Al comando di Reggimento, intanto, c'era stata
una grande animazione: il tenente colonnello Cacciandra e il capitano
Aragone, prima ancora che l'azione si sviluppasse, erano stati
feriti alle gambe. Bettoni stesso aveva avuto il cappotto sforacchiato
da una pallottola di mitragliatrice ma non se n'era neppure accorto
tutto preso com'era dagli eventi. Ad un tratto aveva apostrofato
il tenente Genzardi, l'alfiere, dicendo: «Che cosa aspetta
a sciogliere lo stendardo: non vede che "Savoia" sta
caricando?». E poco dopo aveva ordinato che gli venisse
portato il cavallo: «Dobbiamo caricare anche noi!»
aveva detto ed il maggiore Piscicelli, suo aiutante, aveva dovuto
ripetergli una infinità di volte: «No, Sandro, tu
non devi caricare: tu devi restare qui a dirigere le operazioni».
[22] Ma Bettoni non ebbe pace finché
non giunsero i primi ufficiali ad annunciargli che il nemico era
annientato: «Lo ricordo mentre tornavo dalla carica: era
in piedi sulla Balilla, pallidissimo, e teneva una mano
appoggiata allo stendardo... ». [23]
A mano a mano che i suoi uomini ritornavano. Bettoni
li abbracciava commosso: «"Savoia" ha caricato!»
dicevano gli ufficiali; «"Savoia" ha caricato!»
rispondeva Bettoni, ma era ansioso di conoscere con esattezza
le sue perdite. Sul campo di battaglia, infatti, era cominciata
la raccolta dei feriti e dei caduti. Erano le nove e trenta.
«Com'era triste e doloroso questo incarico
che toccò proprio a noi del 4° e che durò per
alcune ore ininterrottamente. Fu allora che giunse anche il cappellano
militare ed io ne approfittai per tornare al comando a chiedere
aiuto. Bettoni, al quale mi presentai dando le novità dello
squadrone (11 caduti e 27 feriti), mi abbracciò forte forte.
Per lui, come per Compagnoni, la mia presenza aveva del miracoloso
dato che si era sparsa la voce che fossi caduto in combattimento.
Chiesi subito che fossero inviati sul campo degli automezzi per
il trasporto dei feriti e degli uomini del l° squadrone, rimasti
fino allora inattivi, per dare una mano. Procedemmo così
alla raccolta dei feriti, sia nostri che russi, poi a quella dei
caduti e infine al recupero del materiale abbandonato dai nemici.
Il campo restava però disseminato di una quantità
di cavalli uccisi ». [24]
Si seppe così, finalmente, la situazione:
i seicentocinquanta cavalieri avevano combattuto contro duemila
siberiani. Le perdite per il «Savoia» ammontavano
a 32 morti (3 ufficiali), 52 feriti (5 ufficiali) e più
di 100 cavalli fuori combattimento. I russi avevano invece lasciato
sul campo 150 morti, 300 feriti, 500 prigionieri, quattro cannoni,
dieci mortai, cinquanta mitragliatori e centinaia di fucili. Tra
i prigionieri c'era un intero comando di battaglione. C'erano
anche alcuni plotoni di mongoli interamente equipaggiati con uniformi
italiane preda dell'attacco alla «Sforzesca».
I feriti italiani vennero distesi su teli da tenda
divisi in due gruppi: i più gravi e i meno gravi; dagli
ospedali da campo, infatti, era giunta notizia che non ci sarebbe
stato posto per tutti. Bossi, «il cavaliere solitario»,
aveva il ventre segato in due da una raffica e fu messo tra gli
irrecuperabili, ma trovò il modo di chiamare un compagno
per farsi spostare di posto: non aveva nessuna voglia di morire
(e infatti non sarebbe morto). Un suo compagno, invece, ormai
esausto, chiese solo di poter baciare lo stendardo.
Sul campo, soldati e ufficiali si dirigevano verso
i luoghi dove avevano visto cadere i loro colleghi: Litta fu trovato
col volto rivolto al cielo, l'uniforme impeccabile, le mani guantate
e la bustina tenuta tesa dalla stecca: un soldato si chinò
e tolse dal copricapo la bacchetta di legno dicendo: «Questa
la terrò per ricordo». Scarpelli raccolse invece
la sciabola del maggiore (il padre della vittima, ottantenne generale,
nel riceverla qualche tempo dopo si metterà sull'attenti
come una recluta). [25] Il caporal maggiore
Bottini, vagando tra i cavalli, trovò Palù steso
in una pozza di sangue e gli tolse la sella per consegnarla a
Gotta. Alcuni soldati ritrovarono invece Abba, con il volto abbellito
dal caratteristico sorriso e sul petto la macchina fotografica
ancora aperta. Man mano che un camion era carico di feriti faceva
ritorno al comando. Dopo i primi arrivi, Bettoni sembrò
non rassegnarsi a quella vista e andò a sedersi sul predellino
della sua auto con il volto tra le mani. Casanova lo vide e gli
offri un caffè che Bettoni rinutò forse per la prima
volta in vita sua: «Aveva le lacrime agli occhi e mi chiese:
"Casanova, pensi che i genitori e i parenti di questi ragazzi
capiranno che io non avevo altra scelta?" ». [26]
Poco dopo arrivarono alcuni ufficiali di cavalleria
tedesca che erano di collegamento con un reparto operante alla
sinistra del Reggimento: dalle alture vicine avevano visto tutto
e per la prima volta manifestavano un'ammirazione mista ad incredulità
nei confronti degli italiani. Si avvicinarono a Bettoni e scattando
sull'attenti espressero la loro ammirazione: «Herr Colonel,
noi queste cose non le sappiamo più fare». [27]
Bettoni ringraziò e fece spiegare ancora
una volta lo stendardo, poi radunò i suoi uomini e ordinò
di presentare le armi in direzione di quota 213 non mancando di
ricordare che il «Savoia Cavalleria» compiva proprio
in quei giorni il suo 250° anno di vita. Subito dopo tenne
un breve rapporto. Manusardi aveva suggerito di sfruttare il successo
e di spingere il Reggimento fino al Don, ma Bettoni ritenne che
il reparto non avesse la forza di affrontare un' eventuale nuovo
attacco. Si preferì invece mandare fino al fiume alcune
pattuglie onde evitare eventuali sorprese.
«Ricevetti l'ordine di fare un sopralluogo
con la pattuglia e di proseguire fino a una collina distante circa
otto chilometri per osservare se vi fossero in vista altri reparti
russi. Con noi si mosse anche la pattuglia OC (osservazione-collegamento).
Raggiungemmo la collina e vi rimanemmo fino alle quattro del pomeriggio
». [28]
Più tardi si pensò di mandare un
plotone fino oltre il Don e a tale scopo si offri il capitano
Vannetti che, essendo ferito a una mano, non aveva potuto partecipare
alla carica e che, per questo, sembrava non avere pace. Anche
quel progetto, però, fu sospeso. La sera stessa i camion
dei feriti partirono.
«Trovammo il tenente medico Piemonte che medicò me,
Carboni, Dierna e Mari e via via tutti gli altri. Alcuni, come
Dalmini e Pastorello, morirono quasi subito». [29]
Al Reggimento, intanto, aveva telegrafato il generale Messe promettendo
un gran numero di medaglie: tutti gli ufficiali che avevano caricato
sarebbero stati decorati e anche moltissimi soldati (54 medaglie
d'argento). Litta e Abba venivano proposti per la medaglia d'oro
e cosi pure lo stendardo. [30]
Poche ore dopo, dall'ospedale di Rycowo, arrivò
un messaggio radio del capitano Marchio che diceva: «Subita
amputazione braccio. Nella fierezza del dovere compiuto formulo
voti augurali maggiori glorie glorioso Stendardo».
Note
1 Da un'intervista dell'autore
con Aristide Bottini. Questa testimonianza smentisce quella finora
accreditata, secondo la quale le pattuglie «spararono alcune
raffiche nei campi per vedere se c'era qualcuno».
2 Dal diario di Ferruccio Marino.
3 La stima fu eccessiva. Tre battaglioni,
secondo Messe.
4 Il maggiore Gerardo Conforti
aveva avuto il comando del l° gruppo al posto del tenente
colonnello Cacciandra, divenuto vicecomandante.
5 Da un'intervista dell'autore
con Nino Malingambi.
6 Da uno stralcio del diario del
capitano De Leone.
7 Da un'intervista dell'autore
con Giordano Gallotti.
8 Da un'intervista dell'autore
con Gualtiero Lolli.
9 Vedi nota 6.
10 Da una lettera del sottotenente
Compagnoni al collega Toja.
11 Dal diario di Franco Toja.
12 Dall'intervista a Nino Malingambi.
13 Manusardi aveva già
chiesto aiuto all'inizio della seconda carica, ma il portaordini,
rimasto appiedato, era arrivato al comando poco prima di lui.
«Partii al galoppo tra il fischiare delle pallottole, ma
poiché correvo allo scoperto, ben presto la mia Talpa venne
centrata da una raffica ed io dovetti continuare la corsa a piedi
in un grande campo di grano appena mietuto. Quando giunsi ansante
dal colonnello, questi mi infilò tra le labbra la sua sigaretta
e mi disse: “Stai calmo e spiegati bene”. Io riferii
». (Testimonianza Galbarini.)
14 Da un'intervista al maresciallo
Casanova.
15 Il gesto di Litta fu interpretato
dai più come un atto di passione e di eccessivo zelo. In
realtà (cfr. GIANOLI, Op. cit.), dato il carattere
dell'ufficiale, sembra molto più credibile la versione
secondo la quale Litta tentò con quel gesto plateale di
attirare su di sé l'attenzione del nemico, rimediando alla
spericolatezza di Marchio. Partendo, l'ufficiale esclamò:
«E adesso carichiamo “alla Litta"». (Testimonianza
Manusardi.)
16 Dall'intervista a Giordano
Gallotti.
17 Dal diario del tenente Toja.
18 Dal diario del tenente Toja.
19 Dall'intervista con Gualtiero
Lolli. Subito dopo la carica si sparse la diceria che Abba fosse
stato colpito mentre fotografava. In realtà, come risulta
inequivocabilmente dal carteggio Toja-Compagnoni (proprietà
Manusardi) e dalle stesse foto scattate da Abba e poi sviluppate,
l'ufficiale aveva smesso di fotografare prima di entrare in azione.
20 Da un'intervista dell'autore
con Mario Negri, già sergente del 3° squadrone in Russia.
21 Da un'intervista dell'autore
con Osvaldo Galbarini, già caporal maggiore del 2°
squadrone in Russia.
22 Da un'intervista dell'autore
con Cesco Casanova.
23 Da un'intervista dell'autore
con Giordano Gallotti.
24 Dal diario del tenente Toja.
25 Da un'intervista con il sottotenente
Scarpelli.
26 Dall'intervista a Cesco Casanova.
27 Dal diario del capitano De
Leone.
28 Dall'intervista con Aristide
Bottini.
29 Dall'intervista con Gualtiero
Lolli.
30 Ecco la motivazione della Medaglia
d'oro concessa allo stendardo: «Temperato ad ogni arditezza
e sacrificio, nel corso delle operazioni offensive per la conquista
di un'importante regione industriale e mineraria, assolveva con
immutata dedizione e inalterato coraggio le missioni gravose,
complesse e delicate, fiancheggiando grandi unità nell'inseguimento
di rilevanti ed agguerrite retroguardie avversarie; divampata
repentinamente la battaglia contro il nemico, che, con la potenza
del numero dei mezzi, rompeva bramoso sulla via meridionale del
Don, piombava con fulminea destrezza sulle colonne nemiche delle
quali domava più volte la pervicacia, sventandone l'insidia
e contribuendo, con rara perizia e maschia temerarietà,
allo sviluppo efficace della manovra di arresto. Affrontato all'improvviso
da due battaglioni avversari, durante rischiosa e profonda esplorazione,
ne conteneva l'urto con la valentia dei reparti appiedati e, avventandosi
in arcione sul fianco degli avversari, ne annientava la belluina
resistenza, restituendo alla lotta, con l'impeto corrusco delle
sue cariche vittoriose, il fascino dell'epoca cavalleresca, ed
illustrando il suo nome alla pari dei fasti del Risorgimento e
delle sue secolari tradizioni». Fronte russo, luglio-agosto
1942.
-» Isbuscenskij,
l'ultima carica, di Lucio Lami
288 pag., euro 10,00 (al febbraio 2008)
Edizioni Mursia, 1997 (Prima edizione Mursia, 1970)
ISBN: 9788842522515
Cliccare
qui per acquistare il libro.