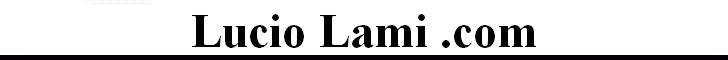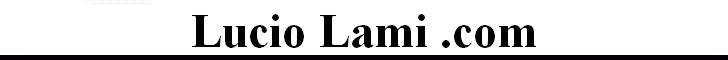» I libri »
Giornalismo all'italiana «
Giornalismo all'italiana
Dalla contestazione al nuovo regime
Prefazione
(Diario di un renitente)
 Il
disagio cominciò con l’autunno caldo del ’68.
Allora dirigevo un settimanale della Rizzoli. Un giorno scrissi
un corsivo per commemorare l’anniversario della morte di Guareschi,
che era stato amico dei miei famigliari: un corsivo innocuo che
parlava del carattere dello scrittore. Il giorno stesso dell’uscita
del giornale Enzo Biagi, direttore editoriale della casa editrice,
piombò nel mio ufficio rimproverandomi di aver commemorato
un uomo di destra. Era la prima avvisaglia del conformismo in arrivo.
(Oggi Biagi è un simpatico estimatore di Guareschi).
Il
disagio cominciò con l’autunno caldo del ’68.
Allora dirigevo un settimanale della Rizzoli. Un giorno scrissi
un corsivo per commemorare l’anniversario della morte di Guareschi,
che era stato amico dei miei famigliari: un corsivo innocuo che
parlava del carattere dello scrittore. Il giorno stesso dell’uscita
del giornale Enzo Biagi, direttore editoriale della casa editrice,
piombò nel mio ufficio rimproverandomi di aver commemorato
un uomo di destra. Era la prima avvisaglia del conformismo in arrivo.
(Oggi Biagi è un simpatico estimatore di Guareschi).
Due anni dopo, ricevetti una telefonata di Nando
Sampietro, direttore di Epoca, che non avevo mai conosciuto.
Mi disse che aveva letto il mio libro sulla campagna di Russia e
che lo aveva favorevolmente commentato con Salvator Gotta. Mi propose
di passare al suo giornale, come caporedattore. Gli dissi subito
di sì, ma poi attesi per mesi che mi richiamasse. Quando
lo fece mi spiegò che non era più direttore della
rivista, che era stato promosso (ut amoveatur) ma che intendeva
mantenere la parola.
Prendendo servizio capii subito come stavano le cose. La Mondadori
sembrava in stato prerivoluzionario. Panorama indiceva
assemblee settimanali che sembravano la perversa imitazione di quelle
della Statale. Le Br «erano sedicenti», la violenza
«solo di destra». l comitati di redazione ricevevano
i comunicati dalle Università come bollettini dal fronte.
Molti funzionari della casa editrice avevano figli già segnalati
tra i «bombaroli» e ispiravano la «resistenza».
I sindacalisti ripetevano senza sosta che «bisognava farla
finita con Epoca, giornale fascista». Il nuovo direttore,
Domenico Agasso, cattolico, dava un colpo al cerchio e uno alla
botte con curiale atarassia. Poi tutti i «quadri» non
di sinistra furono attaccati. Senn, il grande amministratore, che
non si sarebbe più rimesso dal colpo, fu giubilato. Sampietro
rispedito a dirigere un settimanale femminile; Giovanni Cavallotti,
il poliglotta caporedattore di Epoca venne licenziato nel
1974, durante la festa di insediamento del nuovo direttore.
Quando Montanelli fondò il Giornale e venni invitato
in Piazza Cavour accettai l'offerta prima ancora di sapere a quanto
sarebbe ammontato lo stipendio. A Epoca la Pasionaria del
sindacato commentò così la mia uscita: «Peccato,
non ci ha dato il tempo di farlo fuori».
Al Giornale, tra i profughi del Corriere, ci
ritrovammo in molti ex mondadoriani: Torelli, Rossi, e, più
avanti, Grazzini, lo stesso Cavallotti e poi Caputo. Da lì
assistemmo all'interminabile agonia di quello che era stato uno
dei migliori e più venduti settimanali d'Europa. Da lì
assistemmo alle grandi epurazioni nei giornali, delle quali parlo
più avanti, in compagnia di tanti ex collaboratori illustri
di Epoca, da Enzo Bettiza a Cesare Zappulli.
Vent'anni dopo, nel 1994, quando in seguito alla rottura tra Montanelli
e Berlusconi lasciammo, per vie diverse, il fortino dal quale avevamo
combattuto onorevolmente, ci accorgemmo che la pace regnava sovrana
nel mondo giornalistico. La rivoluzione aveva vinto, quelli che
ci avevano attesi, minacciosi, indossando l'eskimo, sulle porte
delle redazioni adesso dirigevano i giornali, i sindacalisti avevano
ottenuto incarichi remuneratissimi, i loro protetti pure, i meno
capaci avevano ottenuto un posto in Parlamento.
Il giornalismo era monocorde e lottizzato al 90 per cento. Gli
editori, in compenso, avevano fatto strame del nostro vecchio contratto
giornalistico e usavano la cassa di integrazione con la stessa disinvoltura
della Fiat, i giornali erano popolati da abusivi, vigeva la legge
del «chi è dentro è dentro, chi è fuori
è fuori», cosa che garantiva agli ex rivoluzionari
un posto a vita.
La stampa era lontana le mille miglia dal giornalismo che avevo
praticato a Epoca, e prima ancora alla Rizzoli o alla Rusconi
o da Mazzocchi, per non dire del Giornale che mi aveva
fatto viaggiare per anni e anni in tutto il mondo senza che Montanelli
mi censurasse mai un solo aggettivo.
Il risveglio era brutale: i nuovi trend professionali
calpestavano la deontologia. Gli slogan dei giovani direttori erano:
«Ciò che avviene all'estero non interessa nessuno»,
«Gli inviati non servono», «La cultura annoia
se non è presentata come spettacolo», e via discorrendo.
Appesi al chiodo la vecchia «Lettera 22», mandai in
campagna le sahariane portate in Africa, le giacche termiche dell'Afghanistan,
le mantelle plastiche usate in Amazzonia e accettai di diventare
il responsabile della redazione milanese de L'Informazione,
che stava per decollare, deciso più che mai a non farmi lottizzare.
Il direttore, Mario Pendinelli, invitandomi a lavorare nel suo giornale,
mi aveva fatto vedere una lista di cento eterogenei finanziatori
dicendo: «Sono tanti che non possono imporci nulla; faremo
un giornale libero, liberale, anticonformista». Ma l'incanto
durò poco. La redazione, a mano a mano che venivano fatte
le assunzioni sembrava, leggendone i nomi, un estratto del Cencelli.
Andare in visita alla sede romana mi dava sempre l'impressione di
entrare in una succursale del Parlamento.
Preceduto da una campagna pubblicitaria miliardaria, L'Informazione
«che prima non c'era» uscì all'insegna di un
dilettantismo impressionante, prima ancora che il suo sofisticato
sistema informatico fosse funzionante. Per giorni e giorni il quotidiano
arrivò a Milano alle ore più disparate senza che i
milanesi si accorgessero della sua uscita.
Travolto da una gestione guatemalteca, il foglio che doveva essere
anticonformista dapprima divenne una voce fortemente clericale (con
i vescovi che firmavano gli editoriali) poi, di punto in bianco
e per ragioni di sopravvivenza, la versione stampata del telegiornale
di Emilio Fede. Le pagine di Milano si tennero fuori da questa ubriacatura,
almeno fino alla mia dipartita.
Ormai diventava sempre più difficile lavorare scansando
le ondate continue dei compromessi. Era il giornalismo intero in
stato di servitù. Bastava leggere le gerenze dei giornali
dove ora il nome dei direttori veniva dopo l'interminabile elenco
dei burocrati, i veri artefici della linea politica, in combutta
con la proprietà, il marketing, la pubblicità, per
non parlare dei padrini politici.
Era ancora possibile creare un giornale libero, un giornale per
i lettori? Era possibile denunciare questa società, questa
politica, questa cultura?
Quasi per rispondere a queste domande avevo accettato il finanziamento
di un privato per creare una rivista di cultura e di politica che
rivendicasse questa impostazione ideologica.
La chiamai classicamente Commentari e ne feci una palestra
di pensiero, chiamando a collaborare gli intellettuali italiani
e stranieri che ne condividevano l'impostazione.
Bastino alcuni nomi: Karl Popper, Alain Besançon, Vladimir
Bukovskij, Marc Fumaroli, Paul Johnson, Vittorio Mathieu, Jean François
Revel, Sergio Ricossa, Domenico Settembrini, Mario Silvestri, Marco
Vitale, Aleksandr Zinov'ev. La rivista fu subito molto apprezzata,
anche se la stampa tacque, riservando le sue attenzioni alle vicende
di Cuore, et similia.
La pubblicazione era uscita da pochi mesi quando l'editore mi
annunciò a bruciapelo che stava per venderla. «Dell'Utri»,
mi disse, «mi ha offerto ottocento milioni».
Non attesi altre spiegazioni e mi dimisi.
La vicenda fece rumore e il Corriere della sera ne raccontò
i dettagli. Io spedii una sventagliata di telegrammi di protesta
a Berlusconi, Letta e a quanti dovevano sapere. Due giorni dopo,
dall'ufficio di Dell'Utri mi chiamarono al telefono per dirmi che
l'acquisto non sarebbe stato fatto.
L'editore dovette smentire frettolosamente la vendita e dichiarò
che il giornale avrebbe continuato le pubblicazioni. Poi chiuse
bottega.
Amici che tenevano un piede nella mia rivista e uno nel Polo mi
spiegarono poi che l'idea di quest’ultimo era di produrre
una rivista adatta a raccogliere quelle firme che ora appoggiavano
Berlusconi, ora lo attaccavano, specialmente sul Corriere,
e di creare una palestra che lasciasse aperta la porta ai compromessi.
Commentari avrebbe potuto servire, ma le mie pretese di
autonomia avevano spinto gli interessati a optare per una nuova
testata.
Poco dopo sarebbe apparsa una fioritura di queste pubblicazioni,
da Liberal a Ideazione, tutte saldamente ancorate
(anche pubblicitariamente) al sistema.
Nel marzo del 1996, mi offrirono la direzione dell'Indipendente.
La Lega stava congedandosi come editore e passando le consegne alla
cooperativa Mediatel.
Il giornale languiva ma, come mi dimostrarono gli amministratori,
avrebbe potuto essere rilanciato grazie al contratto di pubblicità
che legava il giornale all'agenzia parastatale Mmp. La redazione
era in subbuglio: rimasta senza direttore scioperava per averne
uno, sicché il mio ingaggio avvenne fulmineamente dopo una
riunione notturna conclusasi con una lettera impegnativa dell'editore
che anticipava il contratto.
La domanda che mi ponevo in quei giorni era sempre la stessa: si
può far uscire un giornale che risponda ai lettori e non
al regime? Domanda retorica.
Ero da poco insediato quando il contenzioso tra la nuova editrice
e la precedente, leghista, esplose. Quest'ultima portò i
libri in tribunale, chiese il fallimento e senza licenziare i redattori
annunciò loro, semplicemente, che non avrebbe più
pagato nessuno.
Per sistemare questa situazione si attendevano i denari dell'agenzia
pubblicitaria, ma la Mmp bloccò il contratto, quasi che il
suo rapporto fosse col partito di Bossi anziché col giornale.
Sempre sperando che questo equivoco si chiarisse, mantenni in vita
il giornale con pochi collaboratori mentre la redazione restava
in sciopero.
Inutilmente. Il giornale fu costretto a chiudere. E i gestori
se ne andarono sorridenti, dicendomi: «Quando la Mmp perderà
la causa, incasseremo miliardi». Ma intanto il giornale moriva,
sacrificato al principio secondo il quale la pubblicità di
un'agenzia di Stato arriva solo se un partito si fa garante. La
magistratura tacque, il sindacato dei giornalisti fece una modesta
piazzata, e tutto finì.
Spiegai ai lettori, con l'ultimo editoriale, che questa è
la realtà italiana, questo è il regime. Ho dato appuntamento
a tutti da qualche altra parte, magari su un samizdat ciclostilato,
di quelli che i miei amici Maximov e Bukovskij usavano, quando già
il Muro era pericolante, per far arrivare la loro voce a coloro
che ottusamente continuavano a servire.
Nel frattempo mi piacerebbe che chi si lamenta dei giornali, senza
rendersi conto che è il sistema, come la mantide, a blandirli
e a fagocitarli, meditasse su queste righe. Certo, l'informazione
ha problemi che sono di carattere planetario, e ne parlo nella prima
parte di questo scritto, ma quella italiana ne ha, come dico più
avanti, di particolari, di peggiori, che vengono da lontano, e che
favoriscono pericolosamente il degrado intellettuale e morale del
Paese.
-» Giornalismo
all'italiana. Dalla contestazione al nuovo regime, di Lucio
Lami
120 pag., 10,33 euro (al 13 gennaio 2008)
Edizioni Ares, 1997 (collana Sagitta),
ISBN: 88-8155-139-X
Cliccare
qui per acquistare il libro.