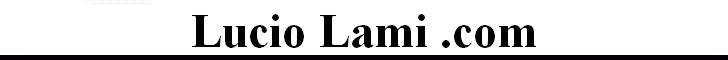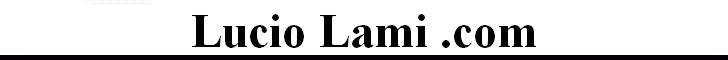» I libri »
Il paradiso violato «
Il paradiso violato
In copertina: l'autore, bambino, sfollato a Varano,
nei campi del mezzadro Fortunin
(Di seguito si propongono l'introduzione e il
primo capitolo)
Un'infanzia inimitabile
 L'idea
di raccontare la mia infanzia da sfollato, durante la seconda guerra
mondiale, in un paesino del parmense e precisamente a Varano Marchesi
mi venne, a metà degli anni Ottanta, a Viamao, un villaggio
sperduto nel sud del Brasile, poco lontano da Puerto Alegre. Viamao
fu una delle ultime tappe dell'avventura sudamericana di Garibaldi
e del suo amico carbonaro Luigi Rossetti. Quest'ultimo, che si batteva
per i repubblicani, localizzato da una banda di volontari al servizio
dell' imperatore, fu alla fine circondato da soldati a cavallo,
trapassato da una lancia, decapitato. La sua testa, infilzata su
una picca, venne portata per la città come un trofeo.
L'idea
di raccontare la mia infanzia da sfollato, durante la seconda guerra
mondiale, in un paesino del parmense e precisamente a Varano Marchesi
mi venne, a metà degli anni Ottanta, a Viamao, un villaggio
sperduto nel sud del Brasile, poco lontano da Puerto Alegre. Viamao
fu una delle ultime tappe dell'avventura sudamericana di Garibaldi
e del suo amico carbonaro Luigi Rossetti. Quest'ultimo, che si batteva
per i repubblicani, localizzato da una banda di volontari al servizio
dell' imperatore, fu alla fine circondato da soldati a cavallo,
trapassato da una lancia, decapitato. La sua testa, infilzata su
una picca, venne portata per la città come un trofeo.
Direte: che c'entra Viamao con Varano?
C'entra, perché mentre visitavo la piazza dove avvenne il
martirio di Rossetti, mi accorsi che la chiesa davanti alla quale
era avvenuto il fatto di sangue era una copia esatta di quella di
Varano.
La facciata bianca, segnata dal tempo
e percorsa da crepe era incredibilmente uguale a quella della parrocchiale
varanese: non di quella d'oggi, un po' anonima e in mattoni rossi,
ma di quella della mia infanzia, quando ancora c'era l'antica parte
anteriore della chiesa seicentesca, bianca, con le sue appendici
laterali spagnolesche, il portale di quercia, le finestre con le
inferriate in ferro battuto e il sagrato erboso cintato di gelsi.
La perfetta somiglianza mi diede subito
un'emozione forte, la stessa che ho provato mille volte, viaggiando
per il mondo come inviato e corrispondente di guerra, ogniqualvolta
un panorama, una casa, un prato, un filare d'alberi mi riportavano
con la memoria al paesino dove nel 1941 ero stato accolto da lontani
parenti, bambino di città sottratto ai pericoli del conflitto.
Varano ha rappresentato, per me, l'imprinting,
il luogo della scoperta della vita, gli anni di un' infanzia alla
Rousseau, a contatto con una civiltà contadina rimasta quasi
immutata dal secolo antecedente, dove il processo biologico era
scandito dalle stagioni, la giornata dal lavoro dei campi, gli affetti
dalla comunione della gente, la pietà da un sentimento religioso
profondo e collettivo.
Su questo paesaggio, lo stesso dell'Angelus
di Millet, avrei visto abbattersi, quando meno me lo aspettavo,
il maglio della guerra, con i suoi lutti e le sue barbarie, i suoi
episodi straordinari di violenza e di disperazione, destinati a
lasciare, in quel contesto bucolico, segni indelebili come di un'
antica pestilenza.
Raccontare la «mia» Varano
significa raccontare la storia di una generazione, quella dei ragazzi
abituati ad andar per nidi e che presto scoprirono una realtà
incredibile: i bombardieri che passavano alti, come aquiloni d'acciaio
diretti alle città, gli spezzoni caduti per caso tra quei
casolari vissuti per secoli nel silenzio, gli Sten trovati
nei fienili col caricatore innestato, le Camel odorose
di miele, piovute dal cielo in lattine di alluminio, le colonne
sferraglianti dei rastrellatori tedeschi e italiani, assetati di
vendetta e i gruppetti allupati dei partigiani, quelli veri di cui
si conosceva spesso la sorte infelice e quelli fasulli che bussavano
di notte per rubare nella case e nei caseifici.
Se gli sfollati adulti cercavano con
ogni stratagemma il modo per sopravvivere alla tragedia in cui erano
immersi, i bambini che non si rendevano conto fino in fondo della
realtà incombente, fluttuavano tra una vita bucolica, simboleggiata
dal pane bianco cotto in casa, e i repentini risvegli per fatti
traumatizzanti. Il nostro paradiso si stava sgretolando a causa
di una tragedia di cui non conoscevamo i contorni, ma di cui sentivamo
i rumori forieri, come l'annuncio di una tempesta.
Di quegli anni, la mia generazione
conserva ricordi velati dal tempo, ma anche tracce subconscie che
le hanno condizionato la vita. Ricordi felici di giornate tra i
covoni di grano o sotto i filari d'uva, ricordi di vendemmie, di
trebbiature, di sagre, di rogazioni cantate tra i campi. Ma anche
ricordi di trambusti notturni improvvisi, di irruzioni armate, di
morti ammazzati allineati sotto le arcate del camposanto, di tam
tam in ore inconsuete, emessi da radio nascoste negli armadi, tra
pigne di lenzuola odorose di lavanda.
Memorie incancellabili di testimoni
troppo giovani, coinvolti in eventi di cui non erano responsabili,
ma che sarebbero stati chiamati a giudicare, in nome dell'innocenza
perduta.
La storia di Varano è la storia
di mille paesini italiani strappati dalla guerra alla loro vita
naturale. La storia dello sfollato di città, che aveva imparato
a correre nei campi a piedi nudi e a raggiungere il fumoso caseificio
per magiare il «tosone» (i ritagli avanzati dalla lavorazione
del formaggio), è la stessa di migliaia di figli della guerra,
che allora non potevano capire, ma che dopo avrebbero riflettuto
a lungo, nel tentativo, non sempre possibile, di far coincidere
i loro sempre vivi ricordi, con la versione ufficiale dei fatti.
Il primo capitolo
Una canonica come casa
Allo scoppio della guerra i miei genitori abitavano
a Modena ma stavano per ritornare a Milano. Quando il treno si mosse
sentii una fitta al cuore ma non piansi. Mia madre sotto la pensilina
si asciugò gli occhi con una mano mentre con l'altra reggeva
mia sorella, di pochi mesi. Mio padre agitava vistosamente il braccio
ma aveva il volto teso. Ero il primo a partire da sfollato. Mia
sorella sarebbe partita l'anno dopo, per Busseto, sempre da parenti
di mia madre.
Quando il treno cominciò a inoltrarsi nella
campagna, staccai la testa dal finestrino e guardai zia Emma, la
«zia di Varano», seduta di fronte a me. Non l'avevo
mai vista, prima di quei giorni. In realtà era una prozia,
una sorella di mia nonna, già sulla quarantina, una bellezza
che sfioriva, nubile, maestra. Vestiva di grigio, con un colletto
di pizzo bianco, portava un piccolo cappello e aveva un'aria dolce
e al tempo stesso severa.
A Parma scendemmo per prendere una corriera azzurra,
col cofano lungo e stretto e una ringhierina sul tetto per tenere
il carico delle valigie. Era stipata di vecchi e di contadine. Quando,
dopo Medesano, imboccò la strada sterrata, cominciammo a
viaggiare in una nube di polvere bianca come la calce che si spargeva
sugli argini, infarinandoli. Varano era vicina.
Quando, dopo Cella, la valle cominciò a restringersi,
zia Emma disse: «Il prossimo paese è il nostro, Varano
Marchesi. È in mezzo ai boschi, ti piacerà».
Avevo una certa ansia di arrivare e di conoscere
l'altra zia, Antonietta, e soprattutto il fratello delle due, l'arciprete,
del quale Emma parlava con compunzione, chiamandolo Don Maldotti
o, più raramente, Don Igino. Cercavo di immaginare la loro
casa, dov'eravamo diretti, alla quale la zia si riferiva spesso
usando un termine a me sconosciuto: «la canonica».
Varano era (ora è cambiato) un paese filiforme
su due livelli. Le sue case si allineavano quasi tutte lungo la
strada calcinata che sembrava morire poco oltre le ultime cascine
sottomonte, dopo l'incrocio per Salso. Arrivando, si incontrava
dapprima il fondovalle con l'agglomerato di case attorno al torrente
Recchio, dominato dai resti di una fortezza cinquecentesca trasformata
in caseificio e, subito dopo, inerpicandosi per una salita che la
corriera affrontava ansimando, si arrivava in una zona piana, assolata,
con rare costruzioni. Passando tra la scuola e il palazzetto rosso
del «podestà» si giungeva al sagrato della chiesa
parrocchiale, dove finalmente l'autobus si fermava ansando.
L'antica chiesa, la cui vetustà contrastava
col fulgore degli oleandri, non guardava la strada ma verso le colline,
in direzione del tramonto. A separarla dal raro traffico dei carri
agricoli c'era un piccolo sagrato erboso cintato da paracarri. Sul
lato destro, essa si congiungeva con la canonica dalla cui mole
era sovrastata e che aveva (e ha) una facciata percorsa da grandi
arcate bordate di mattoni, sotto le quali stavano lo scalone d'ingresso
e un ballatoio spazioso, adorno di gerani, dal quale si accedeva
all'abitazione. Più in alto, sotto le grondaie, una fila
interminabile di finestrine ad arco riprendeva il motivo del ballatoio
sotto stante ingentilendo la massiccia costruzione.
Questa sproporzione di volumi tra la casa di Dio
e quella dei suoi ministri, era dovuta, come mi avrebbero spiegato
più tardi, al fatto che la canonica era stata ricavata da
un fortilizio militare vecchio di secoli. Di fronte ad essa, al
di là di un vasto cortile, c'era un fabbricato che comprendeva
la casa di un mezzadro, le stalle e i fienili, collegati a loro
volta alla canonica da un rustico ad archi, adibito a pollaio, che
chiudeva la corte sul terzo lato, facendone un piazzale che ancora
somigliava a una piazza d'armi.
Intimidito dal luogo, salii le scale tenuto per mano
dalla zia. Camminammo sulla terrazza-ballatoio, inondata di sole,
ignorammo il portone d'ingresso e arrivammo fino in fondo, dopo
l'ultima arcata, dov'era la porticina di servizio, che dava sulla
cucina.
Zia Antonia mi venne incontro festosa, come mi conoscesse
da sempre, ispirandomi subito fiducia. Era una donna piuttosto robusta,
non alta, leggermente ricurva, più vecchia di zia Emma ma
con i modi di una nonna premurosa, il volto largo e sorridente,
la fronte sempre imperlata di sudore o di tintura per i capelli.
Non smetteva di farmi complimenti dando per scontato che comprendessi
il parmigiano, unica lingua che avrebbe mai usato e della quale
si serviva per quelle bordate di umorismo che erano, come avrei
presto imparato, la sua ricetta di vita.
Mi spiegò subito che sarebbe stata lei ad
accudirmi, perché lei era la donna di casa. Zia Emma aveva
altri compiti, più intellettuali, e mi avrebbe seguito negli
studi, quando non avesse avuto impegni con la scuola. Erano entrambe
rimaste misteriosamente nubili. Come Marta e Maria del Vangelo,
si erano divisi i compiti, accanto al fratello prete, a seconda
delle reciproche attitudini.
E lo zio?
Don Igino arrivò di lì a poco. Aveva
il volto largo di zia Antonia ma un' espressione più severa.
I capelli candidi tagliati a spazzola, la chierica larga e ben rasata,
la talare un po' lucida sui gomiti. La figura ieratica e il collarino
candido gli davano un'aria così austera da mettermi soggezione.
«Noi due diventeremo amici», mi disse
con voce bonaria. Poi infilò una mano in un' apertura laterale
della veste, si piegò annaspando, quasi che la tasca non
avesse fondo, ed estrasse una mela profumata, porgendomela.
Poco dopo, cominciò la visita di quello che
avrei, da quel momento in poi, considerato il mio castello.
La cucina di zia Antonia corrispondeva esattamente
a quella di certe locande frequentate dai Tre Moschettieri, così
come me le immaginavo, quando mia madre mi riassumeva, con abbondanti
approssimazioni, qualche pagina di Dumas. Enorme (così almeno
mi appariva), mediamente illuminata, di un bianco un po' affumicato,
col soffitto sorretto da vecchie travi, era dominata da un camino
tanto ampio che la zia vi si inoltrava spesso tutta intera per appendere
le pentole alla catena. Alla sinistra del camino una vetrata smerigliata
celava alla vista un secchiaio di pietra bigia, con una pompa a
mano per l'acqua, che d'inverno spesso gelava, cosicché bisognava
andare in cortile ad attingere dal pozzo con i secchi. Sul lato
destro, dove c' era la stufa a cerchioni, due finestre si affacciavano
sul cortile e quella più vicina al camino aveva il davanzale
all'altezza del tetto dei pollai sottostanti, dal quale andava e
veniva Ciro, il gatto soriano di casa. Alla parete di fronte, due
grandi credenze di modesta fattura ospitavano vasellame vecchio
di decenni, sobrio ma di buona qualità, e suppellettili contadine,
come la grande grattugia a manovella, in legno chiaro o la batteria
di ferri da stiro a carbone, compreso quello lucidissimo, destinato
ai paramenti.
-» Il
paradiso violato.
128 pag., Euro 12,91 (al 3 maggio 2007)
Edizioni Ares, 2001
ISBN: 88-8155-211-6
Cliccare
qui per acquistare il libro.