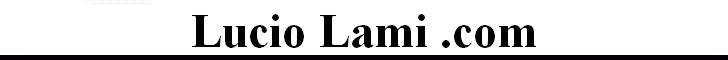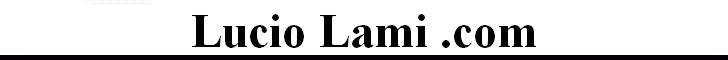» I libri »
Morire per Kabul «
Morire per Kabul
Una lunga marcia afghana
(Di seguito si propongono l'introduzione e il
diario del ventottesimo giorno)
Introduzione
 Questo
diario è stato redatto, sera dopo sera, durante il viaggio
che ho effettuato, da clandestino, alla fine del 1981, nell’Afghanistan
occupato dalle truppe sovietiche. Un viaggio al seguito dei guerriglieri,
durato oltre un mese e portato a termine, tra notevoli peripezie,
con un solo intento: toccare con mano la realtà di questo
nuovo Vietnam dimenticato dall’Occidente. Per tutta la sua
durata, tre domande mi hanno assillato. Le stesse – credo
– che si porrà il lettore: come è potuto accadere
tutto questo? Qual è la reale situazione dell’Afghanistan,
oggi? Quali prospettive può avere per il futuro?
Questo
diario è stato redatto, sera dopo sera, durante il viaggio
che ho effettuato, da clandestino, alla fine del 1981, nell’Afghanistan
occupato dalle truppe sovietiche. Un viaggio al seguito dei guerriglieri,
durato oltre un mese e portato a termine, tra notevoli peripezie,
con un solo intento: toccare con mano la realtà di questo
nuovo Vietnam dimenticato dall’Occidente. Per tutta la sua
durata, tre domande mi hanno assillato. Le stesse – credo
– che si porrà il lettore: come è potuto accadere
tutto questo? Qual è la reale situazione dell’Afghanistan,
oggi? Quali prospettive può avere per il futuro?
Il diario risponde almeno in parte a questi interrogativi; tuttavia,
per inquadrare l’esperienza cronistica nella più vasta
realtà degli avvenimenti, è bene ricordare qualche
dato storico essenziale.
La società afghana è vissuta per secoli come congelata
nel tempo, in un ambiente naturale nel quale le montagne impervie
rendevano quasi impossibili le penetrazioni dall'esterno. Coacervo
di etnie, il paese è rimasto allo stadio della civiltà
tribale fino agli Anni Sessanta, superando indenne l'era delle colonizzazioni,
grazie al ruolo di cuscinetto che russi e inglesi gli riconobbero
dopo aver tentato invano la politica della penetrazione. La mancata
colonizzazione e la neutralità al tempo dei grandi conflitti
mondiali hanno avuto un solo rovescio della medaglia: il mancato
sviluppo del paese, rimasto fino alla metà di questo secolo
allo stadio pastorale.
È solo con le prime e malcomprese riforme di re Mohammed
Zahir Shah (1933-1973) e con quelle appena tentate del generale
Daud (1973-1978) che il paese sembra imboccare, tra molti contrasti,
la via dello sviluppo economico. Daud rivendica anche le terre assegnate
al Pakistan e con i trattori chiede carrarmati, che gli Stati Uniti
gli negano. Lo accontenta l'URSS che da anni infiltra uomini nel
"vuoto afgano". Nel 1955 Bulganin e Kruscev visitano Kabul,
dove pure si continua ad accettare l'aiuto economico occidentale.
Ma già nel 1966 i "prestiti" sovietici superano
quelli di tutti gli altri paesi: nel '71 essi rappresentano la fonte
del 60% degli investimenti afgani.
L'Afghanistan scivola nell'orbita sovietica e l'"aiuto fraterno"
apre la strada ad un colonialismo di tipo classico: il 52% dei tecnici
arriva da Mosca che si accaparra l'esclusiva dello sfruttamento
delle risorse naturali, a cominciare dal gas. L'URSS avvia anche
la preparazione dei quadri dirigenti destinati a rendere la penetrazione
sovietica irreversibile; tra il 1955 e il 1975, 45 mila afgani vengono
addestrati direttamente dai sovietici, in patria o nell'URSS. A
partire dal 1960 tutti gli ufficiali afgani vengono spediti a Mosca
per apprendervi l'ideologia comunista e lo spirito di fedeltà
al paese guida. Sono questi ufficiali che già nel '73 tentano
il primo colpo di mano, ma Daud, che pur tardivamente si è
accorto delle vere intenzioni di Mosca, si rivolge altrove, soprattutto
all'Iran che gli offre un credito di due miliardi di dollari, il
50 % in più di quanto l'URSS non abbia messo a disposizione
in diciassette anni. Daud tratta finalmente anche col Pakistan alla
ricerca di una soluzione negoziata dei problemi territoriali e intanto
rispedisce a Mosca ottocento dei mille consiglieri che gli sono
stati messi alle costole. Troppo tardi. Il Cremlino, facendo leva
sulle due fazioni del partito comunista locale, il Parcham (diretto
da Karmal) e il Khalq (diretto da Taraki) crea una tenace opposizione
facendo rappacificare i due dissidenti. Nasce così il PDPA
(Partito democratico popolare afgano) che pur non avendo che diecimila
aderenti può porre le basi del colpo di stato. Daud viene
assassinato (aprile 1978) e il PDPA conquista il potere con un golpe.
I sovietici ritornano in massa: tremila consiglieri riprendono in
mano le leve dello stato, mentre un servizio di sicurezza, completamente
controllato da Mosca, instaura il terrore.
L'Afghanistan entra nel novero dei satelliti sovietici, grazie
alla firma di un trattato ventennale di amicizia e a 58 accordi
commerciali firmati a partire dalla fine del 1978. Nasce la resistenza
con le grandi sollevazioni delle regioni come il Paktia, il Kunar,
l'Hazaradjat, mentre cominciano le diserzioni in massa dall’esercito.
La popolazione non tollera le riforme di un governo marxista e ateo
che si è imposto con la forza all'ombra dei colonizzatori.
Il governo di Taraki-Amin, succeduto a quello di Daud, entra in
crisi. Amin elimina Taraki e Karmal elimina Amin nel corso di una
guerra mai spenta tra le fazioni arrivate al potere. Mosca avalla,
a tempo di record, ogni cambiamento badando a rafforzare il suo
potere ed intervenendo sempre più massicciamente a puntellare
la situazione, fino a inviare le sue divisioni aviotrasportate.
Nel marzo del 1980 i soldati sovietici in Afghanistan sono già
centomila e Karmal non è che una testa di paglia che copre
l’azione dei nuovi padroni. La presenza russa si rivela per
quello che è: un’impresa coloniale preparata per trent’anni
in un paese che non è mai stato colonizzato.
Ventottesimo giorno
Scrivo in quello stato di sovreccitazione psichica
che viene in battaglia e che non avevo mai conosciuto. Ieri sera
abbiamo lasciato il nostro rifugio verso le 17. Ruhani era contento
di aver reperito un pullmino, un tempo in dotazione a una scuola,
con il quale ci porterà fino a pochi chilometri dalla città
e soprattutto ci ricondurrà a distanza di sicurezza dopo
l'attacco, favorendo la difficile manovra di sganciamento. Il veicolo
è camuffato da automezzo agricolo e sul tetto ha un carico
di legname. Prende una strada che sembra il greto di un fosso e
scende. Ci scarica a cinque chilometri da Ghazni, alla quale si
è avvicinato nascosto dentro un canalone naturale.
Il cielo è torvo, ma il vento tende a sgombrarlo
dalle nubi. Il commando è composto da una sessantina di uomini
che si sono ammassati inverosimilmente nell’automezzo.
Ci scaricano presso un casolare, sotto un enorme
albero rinsecchito nero di corvi. Ai suoi piedi viene steso un mantello:
Ruhani e il "comandant" vi si inginocchiano per primi,
in preghiera. Poi vengono impartiti gli ordini e i mujaheddin nascondono
le armi sotto i patù e si avviano, a due a due,
verso la città, come contadini che ritornino dai campi. Per
ultimi partono i due comandanti dietro ai quali marciamo Jacques
e io. La periferia è grigia, fatta di case-fortezza e le
strade scorrono tra alte mura di cinta. Due elicotteri si alzano
in volo e ci passano a più riprese sulle teste. Dico a Ruhani:
"Ci buttiamo nel fosso?" Dice: “Se li insospettiamo
è finita." In pochi minuti il cielo imbrunisce e gli
elicotteri rientrano.
Facciamo il nostro ingresso nelle strade deserte
del capoluogo, camminando con passo felpato. Presso una moschea
ci viene incontro un vecchio che ci stava aspettando e ci fa cenno
di seguirlo. Entriamo in un orto e poi in un portone, infine in
una stanza grande e ornata di piante verdi. Il vecchio ci serve
la cena. Guardo allibito Ruhani che mi previene: "La notte
è lunga e non si combatte a stomaco vuoto. Anche i mujaheddin
sono andati a mangiare col 'comandant'."
Il vecchio racconta: Ghazni viene attaccata ogni
notte, ci sono anche bande di guerriglieri che di giorno lavorano
in città e di notte sparano. I kalkisti, che erano dodicimila,
ora sono soltanto duemila: molti sono morti, molti sono passati
alla resistenza; li hanno rimpiazzati i russi. La città vive
col coprifuoco, scarseggia l'acqua, le è stata tolta la luce
elettrica che usano solo i sovietici.
Usciamo nel buio, verso le 21: il cielo si è
rasserenato ma la luna è nascosta dalle montagne. Si odono
raffiche di mitraglia, perché qualche altro commando è
già al lavoro. Un mortaio russo spara colpi radi, forse di
inquadramento. Di tanto in tanto, un bengala illumina a giorno l'abitato.
La paura prende la forma di un sottile nervosismo: Jacques mi chiede
una sigaretta e io mi sorprendo a insultarlo, sottovoce, stizzosamente.
Camminiamo in fretta verso la parte della città
che si trova in collina: le case sono già sbarrate; ad ogni
angolo mi aspetto una sorpresa che fortunatamente non viene. Dall'alto,
vediamo il cuore della città occupato dalle installazioni
militari russe, illuminate a giorno dalle fotoelettriche e cintate
da reti metalliche e da reticolati. Due fari sciabolano luce sui
quartieri bui.
Marciando al riparo di un muretto, arriviamo ad una
moschea dove mani invisibili ci aprono la porta. Ci fanno sedere
in un angolo, al caldo, mentre i due comandanti e i vari aiutanti
siedono a rapporto, esaminando le informazioni fresche che la gente
del luogo ha fornito. Gli obbiettivi sono due: distruggere la scuola
con chi c'è dentro, catturare, se possibile, un po' di armi.
Usciamo nel vento freddo e riprendiamo il cammino: adesso le porticine
degli orti si aprono come per incanto e noi ci avviciniamo alla
zona militare mimetizzati dagli alberi da frutta e dalle casupole
disabitate. Quando ci fermiamo, dietro un rudere, siamo a poche
centinaia di metri dalla scuola, che nereggia come un fortino ad
ogni bagliore. Pochi cenni di mano e le squadre si dividono, partendo
in direzioni opposte per aggirare l'obbiettivo. Ci avviciniamo un
altro poco e ci fermiamo dietro un muretto. Il luogo diventerà
il punto di rifornimento di munizioni per le due squadre.
Il buio è profondo e il gelo aumenta. Ruhani
comanda il gruppo di destra, Barakot quello di sinistra: si sono
accordati per riunirsi sull'obbiettivo.
Passa così quasi mezz'ora, poi una tracciante
rossa lacera il cielo e un grido terribile riecheggia nella valletta
al centro della quale c'è la scuola: "Allah-o-akbar!"
("Dio è grande").
È il segnale. Vedo, alla mia sinistra, il
mitragliatore cinese della squadra di Barakot emettere lingue violacee.
A destra aprono il fuoco i Kalashnikov di Ruhani. Subito, una mitragliatrice
pesante risponde dalla scuola e l'aria si riempie di fragore. Il
crepitio aumenta e gli attaccanti si avvicinano sempre più
all’obbiettivo. A tratti, il fuoco sembra diminuire, ma poi
riprende con maggiore intensità, sempre più incalzante.
Le mitragliatrici, dalla scuola, intensificano ora la risposta,
con raffiche sempre più lunghe. Il cielo si illumina e le
traccianti indicano con maggiore insistenza gli obbiettivi. Poi,
all'improvviso, le prime esplosioni, fragorose. Sono gli anticarro
dei mujaheddin che centrano la costruzione: vampate rosse illuminano
l'edificio. Le esplosioni si moltiplicano. Un uomo, trafelato, ci
raggiunge: chiede altri razzi. Se li carica sulle braccia e riparte
correndo, senza la minima precauzione.
È l'assalto finale. Guardo l'orologio e mi
accorgo che si combatte da più di un'ora. I boati si moltiplicano
e d'un tratto vedo tutte le finestre dell'edificio illuminarsi a
giorno. Una granata è esplosa all'interno. Grida di dolore
si levano ripetutamente, mentre all'esterno riecheggia ancora: "Allah-o-akbar".
La scuola brucia, ma una mitraglia sul suo tetto non tace. Ed ecco,
d'un tratto, arrivare Ruhani con lo sguardo allucinato, seguito
da Karim, un ragazzone, che si trascina sulle spalle un corpo inerte:
lo tiene per le braccia e le gambe strisciano al suolo. È
Barakot. La mitragliatrice superstite lo ha colto mentre, granata
in mano, stava penetrando nell'edificio in fiamme.
Il cielo è bianco di bengala, il sentiero
è rigato di sangue. Il comandante ha il ventre squarciato
da una raffica e il sangue esce a fiotti così copiosi, che
scorre sulla schiena di Karim e cola a terra. Il ferito viene deposto
al suolo: ha perso il turbante e il suo aspetto è quasi infantile.
Nonostante la gravità della ferita, scalcia e ripete ossessivamente
una frase. Che dice? "Portatemi via con voi." Non ci sono
infermieri, né medici, né medicinali, né barelle.
Si tenta di portare il comandante a braccia, ma cade. Allora lo
si depone in un patù, ma il mantello si squarcia
e Barakot rotola lungo il sentiero. Qualcuno recupera un pastrano
entro il quale viene deposto il ferito.
"Portatelo all’automezzo," ordina
Ruhani, mentre dà disposizioni per il fuoco di copertura.
Un gruppetto di guerriglieri sta intanto rientrando con un altro
ferito: è un giovane mujaheddin, con la coscia trapassata
da un proiettile. "È uscita la pallottola?" "Sì."
"Allora te la sei cavata."
Ruhani ci dice di andare con gli uomini che trasportano
il comandante. Riprendiamo la via degli orti, mentre raffiche sibilanti
passano fischiando sulle nostre teste.
Gli uomini corrono, tenendo per i lembi il pastrano
dentro il quale rantola Barakot. Per due volte il corpo ruzzola
fuori e per due volte viene rimesso nel cappotto, ormai intriso
di sangue.
Una luna enorme, appena spuntata tra i monti, illumina
la strada. Raggiungiamo la periferia: il ferito viene deposto a
terra e qualcuno va a bussare ai portoni delle case. Nessuno risponde.
Poi, finalmente, c'è chi apre: viene recuperato un lettuccio
di stuoie, di quelli che gli afgani usano tenere davanti a casa
per la siesta. Il ferito, avvolto nelle coperte, viene sistemato
sulla branda, che quattro uomini si issano sulle spalle.
Prendiamo, quasi correndo, la via verso il casolare
dove ci attende l'automezzo. Il corteo ansima e getta ombre lunghe
sul bianco della strada. Ripercorriamo il cammino lungo i muri di
cinta delle fattorie dall'alto dei quali i cani latrano selvaggiamente
al nostro passaggio. Le traccianti rosse sembrano inseguirci, come
comete. I lamenti di Barakot si fanno sempre più radi e dalla
barella scende ora, a fiotti, un acre odore di orina.
La piccola comitiva procede ansimando; nessuno parla.
Ad un tratto, gli uomini che portano il ferito chiedono il cambio:
depongono la barella a terra. Mi avvicino e scopro il volto del
comandante: guarda il cielo con fìssità. Interrogo
con lo sguardo Ruhani che annuisce. Qualcuno si toglie il turbante
e lo lega attorno al viso del morto, in modo da chiudergli la bocca.
Ruhani gli abbassa le palpebre. "È lassù"
mi dice Ismael, indicando il cielo stellato, nel quale sta planando
un Ilyushin, con le luci rossa e blu che lampeggiano.
Adesso procediamo più lentamente. Al casolare
depongono il comandante sotto l'albero rinsecchito che lo aveva
visto pregare qualche ora prima. Arriva anche il secondo ferito,
portato a spalle per chilometri. Mi chiede la sigaretta che sto
fumando e gliela metto in bocca. Sembra sereno, ma quando gli dicono
che Barakot è morto si mette a piangere silenziosamente,
e getta il mozzicone.
L'autista non ha esitazioni: sale sul tetto del veicolo
e scarica la legna, poi, aiutato dagli altri, issa il cadavere sul
portabagagli e ve lo lega con una fune. Il ferito, invece, viene
fatto salire a bordo dove si ammassano anche tutti gli altri. Partiamo
a fari spenti, lentamente. Tutti tacciono e l'odore dolciastro del
fumo invade il torpedone. Ad ogni buca del terreno l'automezzo sussulta
e i piedi di Barakot sembrano bussare sul soffitto; i nostri occhi
si levano in alto, istintivamente.
Arriviamo ad un villaggio dove, non so come, la notizia
della morte del comandante ci ha preceduto. C'è gente in
piedi, sulla piazzetta. Qualcuno piange. Sono stati avvisati i familiari
e sono già arrivate le bambine che all'alba assisteranno
alla sepoltura.
La moglie, come vuole l'usanza, è rimasta
a casa con la sua disperazione. Il ferito viene affidato a una famiglia
amica. Gli altri mujaheddin si disperdono, ripartendo a piedi. Anche
noi dobbiamo raggiungere la zona di sicurezza e riprendiamo, in
cinque, la via della montagna. Marciamo fino al mattino, quando
incontriamo una piccola moschea isolata. Ci gettiamo a terra esausti.
Non riesco a dormire. Karim è accanto a me: si guarda l'abito
coperto di sangue e dice: "Sorry", quasi scusandosi, prima
di voltarsi dall'altra parte e di precipitare in un sonno pesante
e agitato.
-» Morire per Kabul. Una lunga marcia afthana,
di Lucio Lami
Bompiani 1982, De Agostini 1987, Asefi 2001
ISBN: 88-86828-77-7 (Asefi)