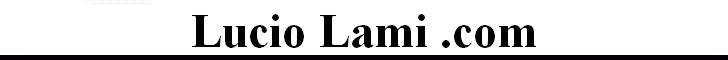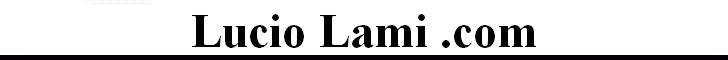» I libri »
La cacciata dei musulmani dall'Europa «
La cacciata dei musulmani dall'Europa
Il Principe Eugenio, il Papato e l'ultima crociata
contro i turchi (1683-1718)
(Di seguito si propone il primo capitolo)
Fuga ad oriente
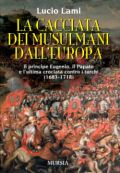 Nell'afosa
estate del 1683, la città di Francoforte sembrava sommersa
da una marea di profughi che giungevano senza sosta dall'Austria
e, in particolare, da Vienna. Sulle strade provenienti da est, interminabili
carovane di carrozze, carri, animali da soma procedevano verso la
città, tra ali di gente stravolta, mentre centinaia di barche
sul Meno ospitavano esuli senza tetto, con le loro scarse masserizie.
Nell'afosa
estate del 1683, la città di Francoforte sembrava sommersa
da una marea di profughi che giungevano senza sosta dall'Austria
e, in particolare, da Vienna. Sulle strade provenienti da est, interminabili
carovane di carrozze, carri, animali da soma procedevano verso la
città, tra ali di gente stravolta, mentre centinaia di barche
sul Meno ospitavano esuli senza tetto, con le loro scarse masserizie.
A chi li interrogava, gli sbandati rispondevano,
con la disperazione dipinta sul volto: "Ci sono decine di migliaia
di turchi che assediano Vienna e altre interminabili carovane di
musulmani stanno risalendo dai Dardanelli. Dalla capitale, i viennesi
sono già scappati in massa; lo stesso Imperatore se n'è
andato con la Corte a Passau, dove il suo governo affonda nelle
chiacchiere. Se anche venissero concentrate su Vienna tutte le truppe
imperiali disponibili, per rompere l'assedio, il rapporto di forze
tra i musulmani e i cristiani sarebbe di dieci a uno".
Tra gli sbandati c'era chi sperava ancora in un intervento
del Papa, ma i più scettici sembravano ormai rassegnati:
"Il Papa si appella al cristianissimo Re di Francia, ma Luigi
XIV, che vuole distrutto l'Impero, è ben lieto che l'imperatore
Leopoldo venga attaccato alle spalle dai califfi. Il Re di Francia
amoreggia da anni con la Sublime Porta".
Non c'erano sono solo i turchi a combattere, con
i loro indemoniati giannizzeri agli ordini del Gran Visir, ma anche
i magiari, insorti contro l'Impero e ora alleati del Sultano, e
poi, il peggio del peggio, gli slavi, soprattutto croati, autori
di crudeltà indescrivibili. I profughi li chiamavano "Kuruss"
e li temevano più di tutti perché impalavano, arrostivano
i prigionieri, li condannavano ad agonie atroci. I cristiani avevano
cercato invano di emularli in ferocia, come avevano fatto gli assediati
di Kaschan, che avevano arrostito in graticola un prigioniero turco,
esponendo lo dalle torri a monito degli assedianti.
Paradossalmente, tra quella folla di scampati c'erano anche due
aristocratici, in fuga da Parigi, che marciavano in direzione opposta,
decisi a raggiungere Wurzburg e di lì la corte imperiale.
Erano il principe Eugenio di Savoia, diciannovenne, scappato dalla
capitale francese come un ribelle e suo cugino, il principe Conti,
genero del Re Sole, che cercava di proteggerlo in quella incredibile
avventura.
I due, trovato alloggio per una notte in una locanda
sul Meno, furono inaspettatamente raggiunti dai fulmini del loro
re, e precisamente dal ciambellano De Raglie, scortato da un drappello
di moschettieri, il quale, ignorando ostentatamente Eugenio si rivolse
a Conti in nome di Luigi XIV: "Se non rientrate con me a Parigi,
immediatamente, la vostra famiglia cadrà in disgrazia e tutti
i vostri beni verranno confiscati. Passando il confine e entrando
nelle terre dell'Impero di Leopoldo potreste anche essere accusato
di alto tradimento, poiché siete un ufficiale di sua maestà".
Conti era pallidissimo. Guardò con pena il
cugino e gli disse: "Non posso far altro". Tolse dalla
sacca una borsa di monete e dal dito un anello ornato da una vistosa
pietra e li diede ad Eugenio. Poi l'abbracciò in silenzio
e seguì il ciambellano.
Eugenio, ignorato da tutti, rimase solo. La villania che gli aveva
riservato l'inviato del Re, ignorandolo, gli ricordava il giorno
della sua presentazione ufficiale a Corte. Anche allora Corti aveva
cercato di aiutarlo dicendo al Re di Francia: "Questo è
mio cugino, Savoia di Carignano, che desidererebbe mettersi al vostro
servizio come ufficiale". E il re, che pure lo conosceva fin
dalla nascita e che forse avrebbe potuto essere suo padre naturale,
lo aveva guardato come fosse trasparente, proseguendo nella sua
promenade senza rivolgergli la parola.
L'odio gli ribolliva nell'anima. Doveva arrivare
a Passau, doveva arruolarsi nelle milizie dell'Impero, doveva combattere
i turchi finché sarebbe stato possibile rivolgere le armi
contro re Luigi, che aveva commentato ironicamente la sua fuga con
le parole "Quale perdita!" e aveva mandato a riprendere
Conti lasciando lui al suo miserevole destino.
Aveva abbandonato Parigi, il 26 luglio di quel turbolento
1683, con pochi denari presi a prestito e l'unico abito che indossava.
Il suo magnifico cavallo era un regalo del cugino il quale, prima
di lasciarlo, gli aveva donato tutto quello che aveva con sé:
mille fiorini e il suo anello. Ma sarebbero bastati per rivestirsi,
equipaggiarsi e presentarsi a Corte?
L'indomani si alzò all'alba, fece sellare
il cavallo e prese la strada per Ratisbona, raggiungendo il Danubio.
Lungo il fiume risalivano nuove torme di sfollati portando le voci
di una disfatta imminente delle armate imperiali.
Arrivò febbricitante per la stanchezza. Cercò
la casa del conte Tarini, un aristocratico savoiardo per il quale
aveva una lettera di presentazione. Lo trovò in grandi ambasce:
le voci popolari erano tutte vere, Vienna era sull'orlo della catastrofe,
il governo sperava ancora nell'intervento di Luigi XIV, nelle pressioni
del Papa, ma s'illudeva. I musulmani si erano fatti arroganti, tanto
che il Re di Francia aveva dovuto scusarsi col Divan [1]
e col Sultano Maometto IV per aver fatto attaccare dall' ammiraglio
Dufresne i pirati che operavano nel Mediterraneo sotto le bandiere
turche.
Tarini, che dirigeva da Ratisbona una rete di informatori
al servizio del duca di Savoia, Vittorio Amedeo II, nutrì
all'inizio qualche diffidenza per Eugenio che era troppo male in
arnese e sprovvisto di vere credenziali da parte del cugino torinese,
ma presto la situazione fu chiarita. Il 20 agosto arrivò
dalla capitale piemontese un messo di Vittorio Amedeo, un certo
Carrocchio, con una lettera del duca che invitava Tarini ad usare
i massimi riguardi per il giovane appartenente alla sua casata.
Alla lettera era unita una cospicua somma di denaro.
Arrivarono anche messaggi incoraggianti da Luigi
Guglielmo, margravio del Baden, che era figlio di una zia di Eugenio,
e del marchese di Borgomanero, ambasciatore di Spagna presso la
Corte di Vienna e amico dei Carignano.
Acquistato un nuovo abito, procuratasi una scorta
e munitosi di armi e di cavalli, Eugenio che finalmente si sentiva
principe, prese la strada di Passau per raggiungere il cugino margravio
dal quale si aspettava di essere presentato all'Imperatore e posto
al comando di un reggimento.
Era convinto che un ingaggio da ufficiale non potesse
ormai essergli rifiutato, visto che da pochi giorni suo fratello
Luigi Giulio era caduto in combattimento, a Petronel, battendosi
sotto le bandiere dell'Impero. La notizia di quel lutto era stata
una delle cause della sua affrettata partenza.
Arrivò in città sfatto dalla fatica
e come prima cosa si procurò un alloggio per riposare. Era
ancora febbricitante e l'agitazione gli procurava insonnia. Stava
per iniziare una nuova vita, ma i suoi pensieri non riuscivano a
liberarlo da quella passata. Aveva solo vent'anni e la sua giovinezza
era stata infelice.
Si rendeva conto che quella rischiosa fuga stava
imprimendo una svolta decisiva al suo futuro. Un distacco forte
da sua madre, gran dama di corte, ex amante del re, tessitrice di
mille intrighi, genitrice perennemente occupata altrove e tuttavia
affettuosa e incombente.
Un distacco drammatico, quasi a tradimento, dal re-padrone,
visitatore assiduo, prima, persecutore poi di sua madre, additato
da molti, probabilmente a torto, come il suo vero padre, l'onnipotente
per il quale aveva avuto, da bambino, un'autentica devozione, ricambiata
da un'antipatia manifesta e crescente, trasformatasi presto in indifferenza.
Un addio alla Francia, sua terra natale, della quale
tuttavia, da buon savoiardo, non si sentiva figlio, lui, consanguineo
dei duchi del Piemonte e pronipote di quel Mazarino che aveva trasformato
la Corte del Re Sole in dominio degli italiani.
Mettendosi apertamente contro re Luigi, usciva da un universo eliocentrico
nel quale l'avvenire dei rampolli dell'aristocrazia dipendeva quasi
sempre dai capricci di un sovrano.
Adesso non aveva altro desiderio che di andare a
battersi contro i musulmani e per questo leggeva e rileggeva, postillandolo,
un libro del quale parlava tutta Parigi: "Della guerra del
turco", dell'italiano Raimondo Montecuccoli. Il vecchio feldmaresciallo
dell'Impero appariva a lui, e a tutti i giovani di quel tempo, come
il modello ideale dell'uomo d'armi.
Avviato da giovane alla carriera ecclesiastica,
a 16 anni Montecuccoli si era arruolato come semplice soldato al
servizio degli Asburgo partecipando a numerosi eventi della Guerra
dei Trent'anni e diventando presto ufficiale per le sue gesta sul
campo. Fatto prigioniero dagli svedesi, aveva per tre anni studiato
a fondo le riforme militari di un grande stratega, re Gustavo Adolfo
di Svezia. Il risultato di questi studi erano stati i suoi "Trattato
della guerra" e "Dell'arte della guerra", considerati
capolavori di innovazione dai condottieri di tutta Europa. Tra il
1661 e il 1664 aveva comandato le forze cattoliche contro i turchi,
sconfiggendo li. Aveva poi rivolto le sue truppe contro gli attacchi
della Francia, riuscendo, nel 1673, a ricacciare il generale Turenne
oltre il Reno.
Ad affascinare Eugenio era la filosofia di guerra
del Montecuccoli; infatti, se per Machiavelli era la politica a
dover determinare gli scopi della guerra, per Montecuccoli la guerra
trovava ragione d'essere in se stessa, come costante della storia,
ed era l'unico strumento capace di definire l'identità stessa
dell'Impero.
Eugenio, che da principio aveva aspirato a battersi
contro i turchi per il solo fatto che erano alleati del Re Sole,
ora si convertiva all'idea della grande difesa della cristianità
contro la minaccia musulmana. Dal punto di vista delle tecniche
militari, gli aforismi del Montecuccoli gli sembravano punti di
riferimento straordinari per il completamento di quella cultura
militare di impronta francese che aveva ricevuto dal precettore
Sauveur. Lo stratega italiano, infatti, rivoluzionava tutto: la
tattica, l'uso dell'artiglieria, l'aumento delle armi da fuoco rispetto
alle picche, e soprattutto la logistica. Nello stesso tempo, per
Montecuccoli, il Turco diventava il "nemico perenne" del
quale venivano esaminati i pregi militari affinché se ne
trovasse l'antidoto, poiché "era necessario opprimere
o essere oppressi, uccidere o essere uccisi".
Note:
1 – Consiglio di governo
-» La
cacciata dei musulmani dall'Europa. Il Principe Eugenio, il
Papato e l'ultima crociata contro i turchi (1683-1718)
di Lucio Lami
230 pag., euro 18,00 (al marzo 2008)
Mursia Gruppo Editoriale, 2008
ISBN: 9788842539469
Cliccare
qui per acquistare il libro.